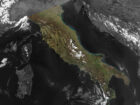“Ius soli”: la dignità e l’orgoglio della civiltà romana e italica
“L’unità della storia d’Italia è data ovviamente dal quadro geografico, ma ancor più dalle molteplicità etniche e culturali, quelle remote e quelle sopraggiunte nel tempo fino alle immigrazioni dei nostri giorni, dalla vitalità cangiante dell’urbanesimo, dalla convivenza armonica e dissonante dei regimi centrali e delle autonomie, dalla persistenza degli idiomi locali e delle lingue comuni (il latino, l’italiano) (…) Nel sistema del dominio di Roma, della Repubblica prima, dell’Impero poi, non erano contemplate gerarchie etniche concepite come immutabili perché risalenti a un nucleo primordiale: altrimenti i romani si sarebbero detti “nati dalla terra” (come gli ateniesi) e non discendenti di profughi venuti dall’Oriente (… ) Questo significava attribuire un valore assoluto non all’origine ma alla storia” (Andrea Giardina, docente di “Storia romana” presso la Scuola Normale di Pisa).
Gennaro Cucciniello
“Blut und Boden”, “Sangue e Suolo”. Una coppia che il Romanticismo tedesco è riuscito a rendere fatidica e della quale il nazionalsocialismo si è appropriato imponendone un’accezione allarmante. Ma a ben guardare si tratta di qualcosa di molto simile a un sistema di coordinate cartesiane entro il quale si può racchiudere la storia del genere umano. Da una parte la discendenza biologica dalla quale si esce e che si concretizza in termini genealogici; dall’altra il luogo nel quale si nasce e che può essere legato a ciascuno di noi secondo la familiarità che le passate generazioni gli riconoscevano. Delle due parole-chiave che a quei due termini archetipici si riferiscono, la “nazione” tende a privilegiare il carattere familiare e tribale della nostra origine, la nascita appunto; mentre la “patria” si rifà più propriamente alla terra dei padri, che noi sentiamo nostra in quanto fu anzitutto loro.
Roma, fedele alla mitica consegna del suo fondatore, fondò le basi del suo cammino imperiale e universalistico sulla solida, concreta base del diritto di ogni membro della sua civitas, l’insieme dei cives, a condividere gli stessi diritti e le stesse prerogative. L’affermazione “civis Romanus sum”, che risuona con la medesima solennità proferita dall’oratore Cicerone e dal tessitore Saulo, ebreo di Tarso, ha il medesimo significato: e traccia una barriera invisibile ma rigorosa tra chi è civis Romanus e chi non lo è: chi è peregrinus, straniero, e come tale certo anche hospes, che però può diventare facilmente un hostis, un nemico. Ma, espandendosi rapidamente tra VIII e I secolo a.C., Roma apprese una lezione sconvolgente: più la sua potenza si allargava, più diminuiva la coesione interna dei suoi abitanti mentre attorno a lei si moltiplicavano peregrini, hospites, hostes, barbari.
Il diritto di cittadinanza romana, che poteva essere concesso a intere comunità e a singole persone, divenne un vero e proprio motore di aggregazione, producendo fedeltà e lealismo. Poiché, con la ridefinizione imperiale dello Stato, la concessione del diritto di cittadinanza era stata riconosciuta una prerogativa dell’imperatore, essa si trasformò in un motore della rivoluzionaria concezione secondo la quale l’Urbs si riconosceva e s’identificava con l’Orbis: essere romano acquisiva un significato universale, quanto meno entro i confini dell’impero ai quali si attribuiva una potenzialità di espansione illimitata.
Con la Constitutio Antoniniana del 212 d.C., l’impoeratore Caracalla compì il passo definitivo sulla via di questa dilatazione del diritto di cittadinanza fino allo svuotamento del suo contenuto di status privilegiato e alla sua coincidenza con una pienezza di prerogative giuridiche di tipo universalistico. Gli abitanti dell’impero erano tutti cittadini romani. Tutto ciò, comunque, includeva un problema ulteriore. L’impero aveva già cominciato a entrare in una crisi complessa, un dato qualificante della quale era il calo demografico con i conseguenti immediati macrofenomeni dello spopolamento delle campagne, della flessione della produzione, della crisi militare, dell’aumento dell’insicurezza. Il collegare saldamente e strettamente la condizione dei singoli alla stabilità dello Stato apparve come un provvedimento quanto mai lungimirante.
La frammentazione e la confusione tecnosociologica ed etnoculturale di oggi richiede una ridefinizione in termini di nuova coscienza identitaria. E’ una sfida alla quale rispondere con coraggio. Alla pressione di genti che in numero sempre più consistente giungono da paesi che lo sviluppo postcoloniale ha messo in crisi e che si vanno insediando in paesi a loro volta compromessi dall’arresto o dall’involuzione dello sviluppo demografico, non si può rispondere se non con una scelta forte, esemplare, in grado d’infondere speranza e fiducia: fare del paese nel quale si nasce, anche se i nostri genitori sono venuti da lontano, la propria patria. Che non equivale affatto a un ricominciare da zero né un imporre una cultura estranea, ma, al contrario, ad accettare un’eredità consolidata e prestigiosa fatta di lingua, d’istituzioni, di tradizioni, di valori. Tanto meglio poi se i nuovi cittadini sapranno immettere nella loro nuova patria anche il contributo delle tradizioni che i loro padri e le loro madri avranno loro tramandato. Dallo ius soli potrà nascere una società futura differenziata, non livellata: le differenze sono valori, ed è necessario affrontarle forti di un cultura dell’et-et, e non dell’aut-aut.
Una futura società di bastardi? Ebbene, sì: e dobbiamo dirlo con dignità e con orgoglio. Siamo tutti bastardi. Lo siamo sempre stati. Le società pure sono frutto di lontane mitologie illuministiche e romantiche del tutto prive di concreta verifica storica. Proprio l’impero romano, che ai suoi massimi livelli almeno dal II secolo d.C. ha espresso imperatori iberici, illirici, arabi, siriaci e perfino berberi (e più tardi, in età bizantina, macedoni e anatolici) è prova di tutto questo. L’Italia, come terra avanzata nel Mediterraneo e protesa a sud, è obiettivamente in prima linea. Se riesce a rovesciare la situazione che si sta prospettando e da futura cavia imporsi come futura protagonista, avrà vinto la sua battaglia per la sopravvivenza e per la civiltà. E dato un esempio di lungimiranza ai governi europei, che stanno dimostrando di averne tanto bisogno.
Franco Cardini
(da “la Repubblica” di venerdì 21 luglio 2017, pag. 3)
Lo “ius soli” spiegato dall’”Ulisse” di Joyce
Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro dell’ignoto. Una fobia che, come ammonisce Amleto, ci spinge a sopportare i mali che abbiamo, piuttosto che “involarci verso gli altri che non conosciamo”. Amleto è uno dei fantasmi che infestano l’”Ulisse”, e il libro di Joyce è una mano tesa all’altro che spaventa. Involarci verso chi non si conosce può terrorizzare, ce lo dicono le vicende di oggi, italiane ed europee, e le reazioni scomposte a un fenomeno migratorio epocale ma da governare. E’ questo il messaggio dell’eroe degli anti-eroi, Leopold Bloom, uno straniero in casa propria, un outsider persino tra le sue quattro mura.
Quando nel romanzo un gretto nazionalista antisemita lo insulta –lui figlio di ebrei ungheresi, trapiantati nella cattolicissima Irlanda- domandandogli quale sia la sua nazione, egli risponde con una lezione di ius soli che ancora oggi a volte sfugge: “L’Irlanda. Sono nato qui”. Bloom è un uomo normale, eppure straordinario. Sa che “l’amore è il contrario dell’odio”, ed è in grado di rispondere alle offese con una risata. Come il suo creatore, che seppe depotenziare anche il Duce, ribattezzandolo Benito Muscoloni. Perché la questione dell’identità nazionale può anche essere oggetto di facezie. Era stato un altro grande irlandese, Daniel O’Connell il liberatore, campione delle lotte per l’emancipazione dei cattolici nell’Ottocento, a suggerire –prendendo per i fondelli persino un inglesissimo Lord Wellington venuto al mondo a Dublino- che non basta nascere in una stalla per essere dichiarati cavalli.
L’ambiguità di queste situazioni nasce da un termine abusato, identità, che a ben vedere significa proprio il suo opposto: la differenza. La somma, o meglio, l’integrazione di differenze. Cosa che sapeva bene l’esule in Joyce; ma anche in Shakespeare, se è vero che il suo Amleto si spinse perfino a postulare l’equazione tra la paura del diverso e quella della dipartita finale. Ed è proprio con l’ambiguità del linguaggio che il letterario combatte la sua guerra. Una guerra ironica, una vendetta col sorriso sulle labbra. Un conflitto che insegna come sia meglio creare ponti che farli saltare. E’ in questo senso che, stando al monito di Richard Ellmann, dobbiamo ancora imparare ad essere contemporanei di Joyce.
Joyce scrive per il futuro, scrive per noi. Come spiega lo studioso Declan Kiberd, “ha composto l’Ulisse per insegnarci a vivere meglio”. Ed è questa la lezione che può ancora impartire ai lettori l’immigrato Leopold Bloom.
Enrico Terrinoni
Enrico Terrinoni è docente di letteratura inglese all’Università per stranieri di Perugia e traduttore, tra gli altri, di James Joyce. Questo commento è stato pubblicato nel “Venerdì di Repubblica” del 4 agosto 2017, a pag. 33.