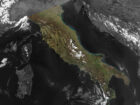E la classe operaia non finì in Paradiso
Il comunismo può attendere. Come descrivere la fabbrica sul set? E il Pci, poi, capirà? Nelle carte segrete del film di Elio Petri del 1971 i dubbi d’autore che un giovane scrittore, oggi, riporta a teatro. Con quale lezione?
“La classe operaia va in paradiso” è un film diretto da Elio Petri nel 1971. L’Italia stava vivendo una situazione politica e culturale esplosiva e drammatica (per intenderci: il film viene premiato al festival di Cannes due giorni dopo l’assassinio a Milano del commissario Calabresi). E Petri col suo cinema entrava nelle fabbriche mostrando la devianza che nasceva nella compulsione del lavoro a cottimo. Il film si chiudeva con un sogno che faceva cadere un muro ma poi mostrava solo la nebbia.
L’omonimo spettacolo teatrale odierno di Paolo Di Paolo è liberamente ispirato alla pellicola del 1971. Con la regia di Claudio Longhi ha debuttato al Teatro Storchi di Modena il 31 gennaio 2018. Questo articolo di Paolo Di Paolo è stato pubblicato nel “Robinson di Repubblica” di domenica 28 gennaio 2018, alle pp. 10-11.
Gennaro Cucciniello
Un titolo che è diventato quasi un proverbio: La classe operaia va in paradiso. Era il 1971, l’altro ieri; pare un secolo fa. E quella luce azzurrina, che invade lo schermo e avvolge lo spettatore dai primi minuti, sembra davvero di un altro pianeta. Si può afferrare e portare su una scena teatrale la luce di un vecchio film? Forse solo a patto di squarciare lo schermo, di smontare il racconto, di vedere che cosa c’è prima, e accanto, e intorno. La scintilla remota che spinse Elio Petri, il regista, e Ugo Pirro, lo sceneggiatore, a dedicare una calda e furiosa estate al progetto. L’officina turbolenta in cui un film nasce prima di nascere: gesti fatti a vuoto, nell’aria; battute provate senza essere attori, senza avere gli attori. Domande che generano domande, dubbi che si sommano a dubbi: e se fosse un film sbagliato? Un film troppo neorealista? Una delle preoccupazioni più forti della coppia Petri-Pirro è proprio questa: se lo confessano reciprocamente, lavorando al soggetto. Temono di conoscere troppo poco la realtà operaia: hanno paura di avere per le mani una storia falsa, e che non venga accettata né dai produttori né dal pubblico. E tuttavia vogliono che manicomio, università e fabbrica, con ciò che li apparenta, siano al centro della vicenda. In manicomio c’è Militina, un ex operaio alienato. All’università, un drappello di studenti in cerca di alleanze strategiche con i lavoratori, su posizioni oltranziste contro i padroni. In fabbrica c’è Lulù Massa, campione di produttività con ulcera e problemi di erezione. “Un personaggio tipico del mondo operaio” lo definisce Petri: ribelle, anarchico, ma supersfruttato.
La fabbrica –scrivono gli autori nella prima, incompleta scaletta- “sorge alla periferia della nostra città, dopo l’ultimo quartiere dormitorio distante un chilometro appena”. Per nostra città intendono Roma. Tanto è vero che l’operaio (prima lo chiamano Cesare, poi Flavio, infine Lulù), “il cottimista più arrabbiato”, nella versione iniziale della sceneggiatura parla in romanesco. Fa strano immaginare la lingua capitolina sulle labbra del milanese Gian Maria Volonté. E infatti, nella stesura successiva, si cambia dialetto e si cambia città. Sale la nebbia, viene fuori la cadenza di Livia/Mariangela Melato e di Lulù/Volonté: “”T’el chi che lavure…”.
Mi piaceva l’idea di portare davanti al pubblico un Lulù prima romano e poi milanese, di mostrare come nasce un personaggio, per quali ripensamenti e progressivi assestamenti. Mi piaceva l’idea di far entrare gli spettatori nel tempo della creazione. Appunti, scambi epistolari, abbozzi, fogli battuti a macchina: “Fatti da tenere presenti: una provocazione fascista, cortei in fabbrica fino agli uffici della direzione, scioperi selvaggi, incidenti di lavoro, scontri con la polizia”. E ancora: “Cos’è un film rivoluzionario?”. E infine, il tempo della ricezione: quel venerdì sera, quella domenica pomeriggio del 1971. L’epoca in cui il film cade. L’attrito che provoca, o l’indifferenza. Così, sono diventati personaggi in scena anche il Regista e lo Sceneggiatore. E’ diventata un personaggio la ragazza stupita dalla visione del film, e la donna annoiata in platea. Enrico, sedici anni, geometra, che si chiede se Petri volesse raccogliere gli applausi di una élite o fare un discorso politico per tutti. Petri che risponde: “A me sta a cuore il discorso di massa. Il discorso di élite è un discorso molto importante, ma quello che mi interessa è la massa, e per questo io credo che la rivoluzione italiana passi attraverso il Pci”. Il militante che s’interroga sull’ortodossia ideologica. Il militante che scrive una letteraccia al “Manifesto” per accusare il film di essere non solo inutile ma perfino nocivo: “Il suo operaio-massa e la massa dei suoi operai sono come li vede la borghesia: lavorano, consumano, dicono le parolacce, impazziscono, sono pecore e si ribellano solo quando perdono un dito, salvo poi ritornare nell’ovile”. Il giornalista che pone domande a una conferenza stampa: “Che cosa significa, in questo momento, un film come La classe operaia?”.
Per porre la stessa domanda a distanza di quasi mezzo secolo, nei mesi scorsi con la compagnia teatrale abbiamo organizzato diverse proiezioni mirate del film. Gruppi di studenti, ex operai in pensione, ingegneri. Tra i ragazzi di un liceo linguistico solo in tre hanno riconosciuto Volonté. Ma alla domanda se il film avesse ai loro occhi qualcosa di attuale la maggioranza ha risposto sì. Superato per la colonna sonora, le luci, l’ambientazione. Attuale per la rivendicazione dei diritti. Allo stesso modo hanno risposto anche gli ex operai.
Io non so se La classe operaia sia davvero un film attuale. So però che ripensarlo per il teatro significa –letteralmente- costringerlo nel presente. D’altra parte, su un palcoscenico non esiste altro tempo: il film è del 1971, ma lo spettatore lo vede, lo ricorda, crede di ricordarlo o lo scopre stasera. E in ogni caso non sta vedendo il film del ’71, sta vedendo uno spettacolo nel 2018. E’ un altro secolo, un’altra epoca del mondo e della sua vita. O magari non era nemmeno nato. Io che sto scrivendo queste righe –per esempio- no, non ero nato. Per questo, solo al presente potevo immaginare il matto Militina e l’insoddisfatta Lidia, la ragazza Adalgisa che sente freddo e il bambino Armandino che si mette a singhiozzare. Le loro parole, i loro desideri. Solo al presente potevo immaginare Lulù Massa che vive o subisce la sua vita. La fabbrica. E la speranza di farcela, sempre assoluta e sempre imprecisa. La necessità di amare. Il bisogno di sentirsi vivi. La battaglia quotidiana per sentirsi utili: “Un uomo ha diritto di sapere quello che fa… ha diritto di sapere a che cazzo serve…”. E’ tutto, comunque, al presente: anche l’operaio che ho inventato per il prologo, un trisavolo che già contiene le generazioni future. Una specie di Karl Marx che riflette sulle condizioni di lavoro degli operai di Amazon. Tutto è dannatamente al presente – e per questo non dà scampo.
Paolo Di Paolo