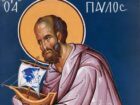Intellettuali illuministi corsari
Le nuove idee del ‘700 si diffusero grazie all’editoria pirata. Intervista a Robert Darnton, autore del saggio “Editori e privati nel secolo dell’Illuminismo”.
L’articolo di Marco Cicala è pubblicato nel “Venerdì” di Repubblica del 21 aprile 2023, alle pp. 89-91.
Nell’intervista non pronuncio l’aggettivo perché può suonare frivolo e magari il professore si offende, però sono rarissimi i libri di Storia divertenti come quelli scritti da Robert Darnton. Divertenti nel senso etimologico di divertere, ossia “deviare, volgere altrove”. Dal monumentale “Il grande affare dei Lumi” al formidabile “Il grande massacro dei gatti”, da “Il bacio di Lamourette” a “Libri proibiti”, gli studi di Darnton, professore emerito dell’università di Princeton, ci dirottano sempre su sentieri del passato –specialmente il XVIII secolo- singolari, poco o per nulla battuti, spesso insospettabili. Ma anche quando si inoltrano in territori meglio indagati, tipo l’impresa dell’Encyclopédie, lo fanno con un’originalità di sguardo che, unita alla felicità della scrittura e a una poderosa erudizione, li rende sempre delle creature speciali nel panorama della saggistica.
L’ultimo titolo non fa eccezione. “Editori e privati” (Adelphi) è un’incursione nei retroscena, se non –fisicamente- nei retrobottega del mercato librario che tra il 1750 e il 1789 diffuse in Europa le nuove idee, non soltanto di quelli che chiamiamo i Lumi, ma più in generale del libero pensiero nelle sue più svariate espressioni: dai pamphlet propugnanti l’ateismo o la sedizione politica ai testi licenziosi, vuoi pornografici. In larga misura, spiega l’autore, quella vasta operazione cultural-commerciale avvenne sous le manteau, cioè clandestinamente, grazie a un circuito piratesco che dalla provincia francese si ramificava fino ad Amsterdam, Liegi, Bruxelles, Ginevra… Di che sfuggire al controllo censorio ed economico –de facto un monopolio- delle autorità parigine. Sotto Luigi XIV, oltre a tutti gli altri, si erano infatti centralizzati nella capitale anche i poteri editoriali, arrecando grave nocumento all’imprenditoria libraria di città quali Lione, Rouen o Tolosa, che pure vantavano una blasonata tradizione nel settore.
Solo Robert Darnton poteva riuscire a raccontare una vicenda del genere col piglio di un intrigo spionistico. Per oltre 450 pagine viaggiamo a bordo di vetture con bagagli segreti nascosti nel doppio fondo, inseguiamo loschi contrabbandieri di montagna e spregiudicati mercanti che, appoggiandone o meno l’ideologia, colsero nella moda delle Lumières una ghiottissima occasione di guadagno. Ma soprattutto ci addentriamo tra gusti e sensibilità di un nuovo pubblico di lettori borghesi che –data la scarsa alfabetizzazione- è ancora ben lungi dal costituire una massa di consumatori, però ne rappresenta in qualche modo l’embrione.
Insomma, come la vita di certi philosophes, anche la diffusione delle loro idee fu un’avventura romanzesca… “E’ così. Sono sempre stato affascinato dagli avventurieri. E, in certo senso, personaggi quali Voltaire lo furono. Quanto alla pirateria libraria, è stata spesso considerata un fenomeno marginale. A mio avviso invece, dal 1750 fino alla Rivoluzione del 1789, svolse un ruolo centrale”, dice Darnton al telefono da Cambridge, Massachussetts, dove vive e ha diretto la biblioteca dell’università di Harvard.
In assenza di diritti d’autore e di copyright, che significa nel XVIII secolo “piratare” un libro?
Essenzialmente significa ristampare all’estero titoli di successo e reintrodurli in Francia sottobanco, “senza lusso tipografico”, come si diceva all’epoca, cioè in edizione economica, a prezzo ridotto, spesso del 50% rispetto a quello imposto da Parigi.
Dalla Francia all’Europa centrale il traffico librario clandestino traccia una curva che lei chiama “La Mezzaluna fertile”. Chi erano all’estero gli editori “corsari”?
Non di rado uomini d’affari perfettamente rispettabili che nel loro Paese agivano in piena legalità. Nel libro ne racconto alcuni. A Neuchatel, in Svizzera, Frédéric-Samuel Ostervald era un notabile di rango, un pilastro della vita politica cittadina. Aveva conosciuto personalmente Voltaire e Rousseau. Allo stesso tempo però era un pirata –almeno agli occhi delle leggi francesi.
Appoggiavano i Lumi o piratavano solo per quattrini?
C’era un po’ di tutto. A Liegi, tale Pierre Rousseau fu un vero militante dell’Illuminismo. Altri si limitavano a simpatizzare con le nuove idee, altri ancora, la maggioranza, erano puri affaristi. Magari di convinzioni conservatrici.
In combutta con i librai francesi di provincia si sfidava l’accentramento parigino.
Dal secolo precedente Parigi esercitava un monopolio autentico sull’editoria. Era un mondo chiuso, corporativo, e un mercato di lusso. I libri si vendevano a caro prezzo. Anche perché, se di buona qualità, la carta rappresentava circa il 50% del costo di fabbricazione di un volume.
E così il commercio dei libri “craccati” esplode, da intrallazzo artigianale diventa industria.
Ritengo che a partire dal 1750 oltre la metà delle opere in circolazione in Francia fossero piratate.
L’offerta rispondeva a un nuovo tipo di domanda.
Una domanda sempre più enorme. A Parigi come in provincia si andava sviluppando una nuova figura di lettore medio, modesto economicamente ma vorace di letteratura e conoscenze. E’ alla fine dell’Ancien Régime che, con la diffusione del libro a buon mercato, inizia a formarsi quello che sarà il grande pubblico dell’Ottocento.
Come si sceglievano i titoli su cui puntare?
L’editore pirata disponeva di una vera e propria rete di spie, di informatori che dalla Francia lo tenevano aggiornato sugli autori, i libri di successo. Di solito erano i librai a trasmettere le segnalazioni. Ma nelle stamperie parigine c’erano pure operai che facevano il doppio gioco, rubavano bozze per venderle al miglior offerente. Autentico spionaggio industriale. Tra i pirati la concorrenza era feroce.
Ma, a parte le operazioni di “intelligence”, qualcuno doveva occuparsi pue sempre del “lavoro sporco”, cioè di introdurre materialmente in Francia i libri riprodotti all’estero.
In genere le spedizioni non avvenivano mediante carrozze, ma su voitures più capienti e più economiche dal punto di vista dei dazi di trasporto. I libri pirata venivano nascosti tra quelli di esportazione legale.
In altri casi per varcare le frontiere ci si serviva di “spalloni”, contrabbandieri esperti.
Contadini analfabeti che conoscevano bene i valichi di montagna. Portavano il carico in spalla. Benché spesso si svolgesse con la complicità dei doganieri, era un lavoro mal pagato e pericoloso. Il contrabbandiere rischiava di essere marchiato a fuoco sulla schiena e fino a nove anni di detenzione sulle navi galera.
Gli autori erano al corrente dei traffici?
Questo è un aspetto interessante. Se l’autore era celebre e facoltoso, poteva addirittura collaborare con gli editori clandestini. E’ il caso di Voltaire. Come sappiamo, lui si era arricchito grazie a un’astuta vincita alla lotteria e a una serie di speculazioni finanziarie. Non avendo problemi di denaro, e conoscendo tutti i segreti del mercato librario, Voltaire non solo tollerava, ma incentivava il pirateggio delle proprie opere. Al suo editore ginevrino e ad altri piccoli stampatori le cedeva gratuitamente. Dopotutto le edizioni clandestine allargavano la diffusione dei suoi scritti. Altri autori non potevano permettersi la stessa liberalità…
Per esempio?
Il filosofo Jean-Francois Marmontel. Non era esattamente spiantato, me nemmeno ricco. Durante un viaggio a Liegi fu avvicinato dall’editore pirata Jean-Francois Bassompierre che con assoluto candore lo ringraziò calorosamente perché la ristampa dei suoi libri gli aveva fatto guadagnare un sacco di soldi. Marmontel non la prese bene. “Lei ruba il frutto delle mie fatiche”, protestò. L’editore rispose che i privilèges francesi non vigevano a Liegi. “Abbiamo il diritto di stampare tutti i buoni libri: questo è il nostro mestiere”, disse. Poi invitò Marmontel a cena a casa sua, assicurandogli: “Vedrete una delle più belle tipografie d’Europa, e sarete soddisfatto del modo in cui le vostre opere vi vengono riprodotte”.
Di che cosa viveva un autore del ‘700?
Anche questo è un aspetto interessantissimo. Ci sto lavorando per un nuovo libro. Non esistendo diritti d’autore, gli scrittori venivano pagati alla consegna e la cosa finiva lì. Prima della Rivoluzione erano perciò in pochissimi a poter vivere soltanto della propria scrittura. Sempre bene informato, Louis-Sébastien Mercier sosteneva che in tutta la Francia non fossero più di trenta. Su circa tremila. Gli altri dovevano destreggiarsi con altre attività.
Nel libro lei cita testi che all’epoca furono bestseller ma dei quali oggi non si ricorda quasi più nessuno.
Spopolavano in particolare i racconti sui retroscena di Corte. Gli “Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry”, un libello piccante di Mathieu-Francois Pidansat de Mairobert. Oppure la “Vie privée de Louis XV”. L’aveva scritto Barthélemy-Francois-Joseph Moufle d’Angerville. Era un resoconto scandaloso sul regno di Luigi XV. Quattro volumi. Ancora oggi una lettura deliziosa. Sono pieni di informazioni. Più dettagliati e divertenti dei moderni libri di Storia.
A proposito di informazioni: prima di dedicarsi agli studi storici lei ha fatto il giornalista. Quell’esperienza ha influito sul suo modo di lavorare e di scrivere?
Penso di sì. Vede, mio padre era un corrispondente del New York Times. Morì da reporter nella Seconda guerra mondiale. Mia madre voleva che seguissi le sue tracce. E per un po’ l’accontentai. Da studente, durante le vacanze, collaboravo con piccoli giornali specializzati in cronaca nera. Come lettore avevo sempre adorato le inchieste. Dopo il dottorato a Oxford tornai negli Usa e iniziai a lavorare anch’io per il New York Times. Trascorrevo le giornate in questura o appresso ai poliziotti. Anche se poi sono passato ad altro, la nera è stata un eccellente apprendistato. Ti insegna a muoverti sul campo e ad essere preciso, chiaro nella scrittura. Ti insegna il rispetto per il lettore. Anche adesso, occupandomi di Storia, cerco di evitare il gergo accademico. Forse la mia passione per gli archivi della polizia e della giustizia, come per gli intrighi del ‘700, deriva da quegli anni di giornalismo.
Però la mamma ci sarà rimasta male.
(Risata). A riparare ci avrebbe pensato mio fratello John, che ha sempre fatto il giornalista e nel 1982 ha vinto il Pulitzer per i suoi servizi sulla Polonia di Jaruzelski e Solidarnosc.
Torniamo al libro, ma con un occhio all’oggi. In tempi di economia digitale, pirateria e monopolismo sono temi di attualità.
Viviamo in un’epoca di nuovi monopoli. Quando dirigevo la biblioteca di Harvard mi sono battuto contro Google e il progetto di digitalizzazione privata, a scopo commerciale, di parte dei fondi. Ma è un fronte ancora aperto.
Nell’evo social certe conquiste dei Lumi che ritenevamo acquisite tornano a vacillare?
Difficile rispondere. Ai suoi albori, nei primi anni ’90, il Web fu giustamente salutato come una rivoluzione positiva. Nello scambio libero e partecipato delle informazioni si scorgeva la realizzazione di un’utopia. Oggi però siamo costretti a ricrederci. I nuovi media veicolano rabbia contro le istituzioni, le autorità scientifiche, l’università, la stampa… Minacciano la democrazia. Che dirle? Malgrado tutto, cerco di rimanere ottimista, sperando che si tratti di un fenomeno transitorio. Ma non vorrei sbagliarmi come Madame de Sévigné quando nel Seicento disse del caffè che era una bevanda destinata a passare presto di moda!.
Marco Cicala Robert Darnton