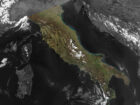La dittatura delle minoranze è il vero pericolo di oggi.
La studiosa Dominique Schnapper spiega perché gli eccessi dell’ultra-democrazia rischiano di travolgere l’Occidente.
Negli ultimi tempi ho cercato di pubblicare, in questo mio sito, articoli e commenti di approfondimento sulle contraddizioni della pratica politica, italiana in particolare. Da un lato ho riportato le valutazioni di Marco Revelli sulla crisi dei partiti politici tradizionali e le ho messe a confronto con le opinioni –del tutto opposte- di Salvatore Lupo. Dall’altro trascrivo adesso le riflessioni della politologa francese Dominique Schnapper sulla cosiddetta “ultrademocrazia”, corredandole delle notazioni interessanti di Esposito e Ricolfi. In verità già nell’ottobre del 2008 io avevo –in una conferenza organizzata dall’Associazione culturale “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino (Avellino) e intitolata “Il ruolo delle classi dirigenti della comunità bagnolese in alcuni momenti storici decisivi: 1648-49, 1820-21, 1948”- tentato di sottolineare la crisi attuale del principio di rappresentanza e del problema dei limiti della prassi democratica, del paradosso necessario della delega ma –insieme- dell’insopprimibile tendenza all’autonomia dell’individuo, in una dialettica di alienazione-riappropriazione del diritto-dovere di cittadinanza. Sono passati sei anni e il problema sta diventando sempre più attuale.
Gennaro Cucciniello
L’intervista di Anais Ginori e l’analisi di Roberto Esposito e Luca Ricolfi.
Un lento scivolare dalla tolleranza all’indifferenza, dalla libertà alla licenza, dalla critica al relativismo assoluto, dall’uguaglianza all’egualitarismo. Il rischio incombente per le democrazie è “l’ultrademocrazia”, esasperazione dei principi che hanno costruito le società moderne, fino a capovolgerli. Nel nuovo saggio, “L’Esprit démocratique des lois”, pubblicato nella collezione Nrf di Gallimard, la politologa e sociologa Dominique Schnapper sostiene che la democrazia deve essere protetta prima di tutto da se stessa e da un nuovo “fondamentalismo democratico” attraverso il quale il cittadino si comporta più che altro da individuo, trasformando in vizi privati le pubbliche virtù. Secondo l’intellettuale francese, figlia di Raymond Aron, il “vivere civile” non è solo minacciato dagli abusi di potere, dall’incremento delle disuguaglianze, dalla violazione dei diritti fondamentali o da nuove discriminazioni. Le democrazie che hanno vinto sui totalitarismi nel Novecento entrano nel XXI° secolo con il rischio di essere vittime del proprio successo e delle smisurate ambizioni interiorizzate da quello che Schnapper chiama l’homo democraticus.
Quali sono i “nemici interni” della democrazia di cui parla?
Mai nella storia dell’umanità le società democratiche sono state così libere, tolleranti, ricche. Ma proprio questa straordinaria evoluzione potrebbe provocare una “corruzione” dei principi democratici che paventava Montesquieu in uno dei capitoli de “Lo spirito delle leggi”. Il termine corruzione non va inteso in senso morale ma come disfunzione di valori. Significa tradire i principi fondativi del “governo repubblicano”, altra espressione di Montesquieu che profetizzava il rischio di “leggi che rendono liberi di essere contro le leggi”.
E’ per questo che ha ripreso il titolo dell’opera di Montesquieu?
Ovviamente non ho la presunzione di fare un seguito ideale di un testo così importante e definitivo. Ma ho ripreso le tesi di Montesquieu per tentare di capire alcune delle dinamiche del presente. Aveva per esempio immaginato una democrazia “estrema” che si sarebbe contrapposta alla democrazia “regolata”. Oggi vediamo che l’aspirazione democratica arriva a spingere gli individui fino al rifiuto di regole e limiti. Le nostre democrazie alimentano un desiderio illimitato di benessere e protezione materiale, sociale, morale. Il sentimento di cittadinanza è stato ormai interiorizzato con effetti in qualche modo perversi. I pensatori greci condannavano l’hybris, forma di orgoglio degli uomini che cercano di superare i propri limiti, comportandosi come dei. La democrazia spinge alla ricerca di un miglioramento perenne, anche perché dalle prime rivoluzioni del Seicento ad oggi abbiamo assistito ad un continuo progresso dei diritti democratici.
L’aumento delle disuguaglianze non è già un tradimento della promessa democratica?
E’ un’illusione pensare che l’uguaglianza politica, sancita dalla democrazia, possa trasformarsi in uguaglianza materiale. Lo Stato sociale è condannato a non soddisfare le crescenti richieste e quindi a essere fonte di frustrazioni e umiliazioni. Le risposte dello Stato sono in ritardo e per natura limitate rispetto a quanto chiedono i cittadini o, per meglio dire, gli “aventi diritto”. Al di là della crisi economica che attraversiamo, esiste uno scarto strutturale tra aspettative e realtà della democrazia sociale.
Così si spiega anche la sfiducia crescente nella politica e nelle istituzioni?
Non stiamo assistendo alla scomparsa delle norme e delle istituzioni ma a una nuova tensione con gli individui democratici che pretendono di scegliere le regole alle quali sottoporsi, scegliendo la propria sovranità. Quando parlo di istituzioni mi riferisco anche a scuola, giustizia, sindacati, religioni e tutte le istanze statali e partigiane che regolano le pratiche sociali nello spazio pubblico. L’homo democraticus ha prima abolito le norme imposte dalla volontà divina, poi ha rifiutato le norme imposte dalla Natura. Ora la contestazione punta contro regole stabilite, ovvero contro la storicità di norme ereditate dalle generazioni precedenti. Ma è una transizione molto delicata perché la democrazia si basa su una comunità di individui che condividono una visione del mondo, è questa l’unica forma di trascendenza repubblicana.
Anche il diritto di critica ha superato ogni limite?
La società democratica è imperfetta, come tutte le società umane, anche se ha la particolarità di sottoporsi all’analisi critica dei suoi membri. Insieme al rischio di democrazia estrema, c’è anche quello di una critica estrema. La contestazione è legittima se si concentra sulle decisioni politiche e sulle persone, non lo è se attacca le istituzioni. Bisogna evitare un fondamentalismo democratico, prediligendo la critica relativa alla critica radicale, cercando di contestualizzare i costi sociali e politici delle decisioni, riferendosi al passato e ad altri esempi nel presente. E’ facile cedere alla denuncia radicale, spesso più visibile sui media e nel mondo intellettuale. Eppure è la critica ragionata e ragionevole, prosaica e autocritica, che forma l’ordine democratico in tutta la sua modestia.
Come rispondere alle richieste di democrazia diretta o di nuove forme di rappresentanza?
La democrazia deve rimanere aperta a ogni discussione e contributo ma le decisioni spettano a organismi rappresentativi e democraticamente eletti. Solo il voto e il suffragio universale permettono ai cittadini più marginali della società di esprimersi alla pari di tutti. La cosiddetta democrazia diretta rischia invece di favorire la tirannia di piccoli gruppi, in particolare di quelli che urlano più forte degli altri.
Sottolineare i rischi della “Ultrademocrazia” non rischia di favorire movimenti reazionari?
Le posizioni reazionarie sono velleitarie per definizione. Né gli individui né le società possono tornare indietro nel passato. Inoltre, avere un approccio reazionario non permette di comprendere quello che sta accadendo. Le democrazie devono rimanere aperte, liberali, senza chiudersi in false nostalgie. I cittadini devono battersi per difendere lo spirito originale della democrazia, nei suoi valori “regolati e non estremi”, per riprendere Montesquieu. Le democrazie non sono condannate alla sconfitta perché il destino collettivo non è mai deciso in anticipo. Da sempre, i democratici si trovano a dover costruire un mondo improbabile.
(Anais Ginori intervista Dominique Schnapper, la Repubblica, 23 febbraio 2014)
L’analisi di Roberto Esposito. (la Repubblica, 23 febbraio 2014, p. 51).
Cosa deve intendersi per “ultrademocrazia”? Diversamente dalla post-democrazia a suo tempo teorizzata da Crouch e Dahrendorf, il concetto implica che la democrazia non è affatto esaurita, anche se sottoposta a una costante deformazione che la mette in pericolo. La tesi di Dominique Schnapper è che lo stress crescente cui essa appare sottoposta non venga dall’esterno –dagli ultimi totalitarismi o dai nuovi fondamentalismi- ma sia l’esito della sua stessa logica, spinta alle estreme conseguenze. Rispetto a coloro che hanno parlato di limiti della democrazia, o di “promesse non mantenute”, l’argomento viene adesso rovesciato. Proprio per aver cercato di mantenere le proprie promesse fino in fondo, la democrazia rischia di avvitarsi in un cortocircuito dal quale non è facile uscire.
Se si guarda in maniera non superficiale a quanto accade, è evidente che le contraddizioni che oggi insidiano i regimi democratici vadano ricondotte al suo stesso dispositivo logico. I due paradigmi che della democrazia costituiscono gli assi portanti –e cioè quelli di sovranità e di rappresentanza- fin dall’inizio non si articolano senza difficoltà. Come integrare l’idea di “volontà generale”, formulata da Rousseau, agli interessi, spesso in contrasto, degli individui che la compongono? Cosa fa dell’insieme di singoli cittadini un medesimo popolo sovrano? Dopo che a lungo l’apparato statale ha rischiato di soffocare la libertà individuale, da tempo assistiamo ad uno sbilanciamento del principio democratico verso il polo contrario. Ma con un esito altrettanto problematico. In un caso come nell’altro –sia per eccesso di sovranità statale che per eccesso di individualismo- a mettere in crisi le nostre democrazie è l’estremizzazione unilaterale di un vettore presente nel suo corredo genetico.
Lo stesso vale per la dialettica tra rappresentanza e partecipazione. Il meccanismo rappresentativo costituisce l’unica maniera, negli Stati moderni, di veicolare la volontà popolare all’interno delle istituzioni. Ma, come è stato ben presto chiaro, è impossibile trovare un modo di collegare stabilmente i rappresentanti alle intenzioni dei rappresentati. E’ ovvio che un certo grado di autonomia dei primi sia necessaria per liberarli da vincoli clientelari o interessi particolari. Ma il tradimento, tutt’altro che raro, delle aspettative degli elettori che ne è scaturito ha di gran lunga oltrepassato il limite, diventando una delle prime cause della disaffezione generale nei confronti della politica.
Anche in questo caso, per comprensibile reazione, l’ago dell’opinione pubblica tende da tempo ad oscillare in direzione opposta. A un eccesso di democrazia rappresentativa si contrappone adesso l’elogio di quella diretta. Se la rappresentanza, come è interpretata dai partiti, appare scarsamente affidabile, è necessario tornare ad una forma di partecipazione diretta, legando senza mediazioni la decisione politica alla volontà dei cittadini. Lo strumento individuato, a questo fine, è oggi la Rete. Che si tratti di un canale essenziale anche per la politica è fuori discussione. Tuttavia il suo uso indiscriminato non accanto, ma contro, le altre procedure di deliberazione minaccia di spingere la prassi democratica al di là dei suoi confini. Mai come in questo caso si può parlare di “ultrademocrazia”, intendendo con tale espressione il controeffetto che un’opportunità, non controllata nella sua misura, può determinare. Il rischio di un’utilizzazione spregiudicata del Web –come lo sperimentiamo in questi giorni in Italia- è duplice. Intanto sta nell’ambivalenza costitutiva del medium. Che da un lato è veicolo di libertà, dall’altro di controllo. Esso include, ma anche esclude, secondo gli interessi di chi ne gestisce il funzionamento. Il secondo possibile effetto perverso della Rete riguarda il suo uso in termini populistici. Attraverso di essa il leader può influenzare, utilizzandola ai propri fini, l’opinione pubblica. Ma anche farsene plasmare al punto di esserne governato anziché cercare di governarla.
Ancora una volta un eccesso di democrazia rischia di metterne in discussione i presupposti costitutivi. Alla base di tale contraddizione vi è, ancora, il rapporto tra il tutto e le parti. Abbiamo imparato da Tocqueville cosa sia la tirannide della maggioranza. Ma adesso, con un rovesciamento speculare, rischiamo di sperimentare la tirannide della minoranza. E’ possibile, e fino a che punto, che una forza politica minore impedisca, con ogni mezzo, alla maggioranza di governare? O, spostandoci in altro ambito, può una modestissima percentuale di elettori svizzeri portare all’approvazione di un documento, come quello recente sulla limitazione dell’immigrazione, contrario ai valori e agli interessi dell’intera Comunità Europea? Non è anche questo un esito ultrademocratico della democrazia?
Il commento di Luca Ricolfi (in “La Stampa”, editoriale del 2 marzo 2014).
“Movimento Cinque Stelle, l’illusione iperdemocratica”.
Ultimamente, qualcuno si è messo a dire che i grillini sarebbero fascisti. I loro metodi sono stati tacciati di squadrismo. E in questi giorni, di fronte alle procedure di espulsione dei dissidenti, è risuonata chiara l’accusa di stalinismo.
A me pare un abbaglio. Un abbaglio enorme. Soprattutto, un abbaglio che rischia di occultare la vera natura del Movimento Cinque Stelle. No, cari critici dei Cinque Stelle. I partiti totalitari del passato erano un’altra cosa. Erano violenti e anti-democratici. I Cinque Stelle sono l’esatto contrario: sono non violenti e iper-democratici. Non violenti, innanzitutto. Perché la violenza e il suo uso politico, come nel fascismo nel nazismo e nel comunismo, sono stati una cosa troppo seria e tragica. Evocarle a proposito di qualche spintone in Parlamento (sicuramente deprecabile, ma pur sempre spintone) significa non avere il senso della misura, e in definitiva nutrire poco rispetto per le vittime di quei regimi.
Il punto fondamentale, però, quello che caratterizza veramente il grillismo, è l’iper-democrazia. Qui è il cuore dell’ideologia Cinque Stelle. E qui sta la sua vera e più grave pericolosità, a mio sommesso parere. Che cos’è l’iper-democrazia? E’ un’ideologia che si è consolidata solo negli ultimi 20 anni, in concomitanza con il trionfo di Internet, ma le cui radici risalgono a quasi mezzo secolo fa, e precisamente al biennio 1968-69. Che cosa è capitato in quei due anni cruciali?
Due cose, fondamentalmente. Nelle scuole e nelle università è nata l’ideologia assembleare, il cui nucleo logico è il seguente: le decisioni le prendono coloro che si riuniscono in assemblea, gli assenti hanno sempre torto. L’idea soggiacente è quella di una sorta di primato morale della politica: se fai politica, se sei impegnato, allora sei un gradino sopra gli altri; se invece non la fai, allora sei un egoista, un opportunista, un edonista, o come minimo un qualunquista. E questo a dispetto del fatto che chi fa politica è una minoranza, e la maggioranza ha altro da fare (pochi lo sanno, ma nel mitico ’68 gli studenti politicamente attivi erano solo 1 su 5). Ecco perché la minoranza politicizzata si sente moralmente superiore, e disprezza profondamente la massa che si astiene dalla politica, cui riserva termini carichi di connotazioni negative: maggioranza silenziosa, apatici, qualunquisti. Il complesso di superiorità della sinistra nasce anche di qui.
Ma c’è un altro evento capitale in quegli anni: il 7 gennaio 1969 nasce un tipo di trasmissione radiofonica completamente nuova, “Chiamate Roma 3131”, che diventerà un modello per decine di altre trasmissioni consimili. In essa gli ascoltatori diventano improvvisamente protagonisti: chiunque può telefonare e intervenire a prescindere da qualsiasi credenziale di cultura, esperienza, autorevolezza. Oggi ci sembra normale ma allora fu un’assoluta novità, che cambiò completamente il rapporto fra pubblico e media. Da allora, sia pure lentamente e gradualmente, si fece sempre più strada l’idea che tutti possono essere protagonisti e, soprattutto, che non è richiesta alcuna speciale dote, competenza o merito per poterlo essere.
Ma veniamo a oggi. Che cos’è il Movimento Cinque Stelle? Per molti versi non è altro che la micidiale fusione di questi due cambiamenti epocali, entrambi risalenti a quasi 50 anni fa. Grazie alla diffusione di Internet, l’utopia di una comunità di decisori potenzialmente universale, in cui tutti decidono su tutto, è sembrata improvvisamente una possibilità reale. Il mito della democrazia diretta, da cui Norberto Bobbio ci aveva sempre messi in guardia, è sembrato finalmente alla portata dei tempi. Una volta acquisito che tutti possono circolare in Rete, una volta stabilito che il discorso pubblico non richiede alcuna speciale competenza, una volta interiorizzata l’idea che chi fa politica è migliore di chi non la fa, c’erano tutte le condizioni per la nascita di un movimento come quello di Grillo. Restava un piccolo problema, un dettaglio non risolto. La maggioranza della gente, la stragrande maggioranza delle persone normali, ha un sacco di cose fa fare e non si diverte affatto a fare politica, a meno di voler chiamare “politica” il fare gli spettatori nei combattimenti di galli e galline che ogni sera ci offrono Floris, Santoro, Formigli, Paragone, eccetera. Da decenni e decenni le inchieste rivelano che i cittadini politicamente attivi sono una piccolissima minoranza (diciamo il 3%) e che la maggior parte della popolazione o disprezza o ignora o assiste passivamente alla commedia della politica. E questo è ancora più vero nel movimento di Grillo, dove i militanti sono circa lo 0,5% degli elettori, ossia qualcosa come 5 persone su 1000. Ciò crea un salto, una vera e propria frattura, fra la grande e silenziosa maggioranza degli elettori, che si limita a votare e tutt’al più a informarsi, e la minoranza degli impegnati, che frequenta sempre meno le sedi di partito superstiti ma, in compenso, inonda la Rete di ogni sorta di pensieri, analisi, insulti, volgarità, esternazioni, più o meno ostili alla grammatica italiana.
Ma non si tratta solo di una frattura, quella c’è sempre stata, anche ai tempi del glorioso PCI. La novità è che ora, con il movimento di Grillo, a quella frattura si dà uno statuto nuovo, esplicito e paradossale. Grillo e Casaleggio sognano una civiltà digitale in cui tutti, seduti davanti al proprio schermo, partecipino alle decisioni fondamentali della comunità. Una civiltà iper-democratica perché tutti possono partecipare, tutti hanno le competenze per farlo, e l’assenza di partecipazione è una colpa, come era nel ’68 e come, sotto sotto, è sempre rimasta nella cultura e nella mentalità della sinistra.
Questa visione della democrazia e della partecipazione genera almeno due conseguenze. La prima è il sostanziale disprezzo per la democrazia rappresentativa, che si basa invece proprio sul principio opposto, secondo cui la gente ha il pieno diritto di non occuparsi attivamente di politica, ed è del tutto normale che il cittadino deleghi ad altri, i politici di professione, il compito di amministrare la cosa pubblica. La seconda conseguenza è il disprezzo per il proprio stesso elettorato, ossia per quei 995 elettori su 1000 che non partecipano alle decisioni in Rete. Questo disprezzo, non il presunto fascismo o stalinismo, è secondo me il vero lato inquietante del grillismo. Perché, nel movimento di Grillo come negli altri partiti, i militanti non sono affatto un campione rappresentativo degli elettori. Spesso sono invece i più aggressivi, i più faziosi, i peggio informati (perché leggono tanto ma solo ciò che li conferma nelle loro opinioni), i meno vicini al sentire comune delle persone normali. Le quali lavorano, studiano, si divertono, cercano la loro via nel mare aperto della vita. L’iper-democrazia della Rete, molto poco democraticamente, le snobba e le esclude, e in questa esclusione rivela il vero volto di se stessa.