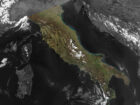La guerra (fredda) di classe.
Globalizzazione e crescita delle disuguaglianze portano sulla scena nuove forme di conflitto tra i gruppi ricchi e quelli disagiati
Ne “La Lettura” del 4 aprile 2021, supplemento culturale del Corriere della Sera, è pubblicato alle pp. 10-11 questo interessante articolo di Maurizio Ferrera.
La seconda metà del XX secolo ha addomesticato il conflitto di classe, temperando il capitalismo con la democrazia e il welfare. Con l’inizio del nuovo secolo, l’equilibrio tra questi tre elementi ha iniziato a vacillare. La ragione sta essenzialmente nell’indebolimento del contenitore: lo Stato nazionale. La globalizzazione e l’apertura dei mercati hanno rimosso confini e barriere regolative territoriali. La delega di poteri e funzioni alle istituzioni internazionali e all’Unione Europea, i vincoli di bilancio e le riforme strutturali necessarie per mantenere competitività di sistema hanno causato profondi rivolgimenti nella struttura economica. L’esito complessivo di questi processi è stato un forte aumento delle disuguaglianze e della insicurezza sociale.
Come già era accaduto a fine ‘800, la “questione sociale 2.0” ha creato un terreno fertile per una nuova contrapposizione di classe e l’inasprimento del conflitto politico. Figlia dell’era industriale, la classe operaia ha perso la propria centralità. La nuova “classe pericolosa” (come l’ha chiamata Guy Standing in un volume intitolato “Precari”, edito dal Mulino) è oggi costituita dai working poor e dai precari appunto: la schiera dei non garantiti, degli irregolari, degli espulsi dal mercato del lavoro. Si tratta dei perdenti della globalizzazione (ma anche della rivoluzione tecnologica) fra i quali si concentrano povertà ed esclusione. E sono proprio queste categorie ad essere gli interlocutori privilegiati (insieme ad alcune frange della vecchia classe operaia e del lavoro autonomo) dei partiti populisti e sovranisti. Alla nuova questione sociale va data una rapida ed adeguata risposta, capace di ridurre il massiccio divario di opportunità fra vincitori e vinti. Ma quale risposta, esattamente? E’ possibile ricreare –su nuove basi e nuova scala- un equilibrio fra capitalismo, democrazia e welfare? Nel dibattito ci sono due orientamenti opposti, uno pessimista e l’altro ottimista.
Il volume appena uscito di Michael Lind, “La nuova lotta di classe” (Luiss University Press) è un esempio emblematico del primo orientamento. Secondo l’autore, è già in atto una nuova guerra di classe (il titolo originale parla di Class War) che oppone uno strato sociale cosmopolita, istruito, ricco, metropolitano (una super-classe dominante) da un lato, e due diversi strati di dominati: quei ceti medi tradizionali che non riescono a stare al passo con la globalizzazione e un sempre più vasto strato di lavoratori situati ai margini, se non del tutto esclusi, dalle dinamiche della nuova economia. Da questa contrapposizione è sgorgata l’ondata di demagogia e di populismo, che ha già fatto registrare in alcuni casi vere rivolte dal basso, anche violente (pensiamo ai Gilet gialli in Francia).
All’origine di questa guerra sta l’ascesa del neoliberismo tecnocratico dall’alto, un sistema di governo imposto dalla super-classe, che ha promosso la deregolamentazione, lo smantellamento delle barriere nazionali, la delocalizzazione delle imprese e il dumping sociale, l’indebolimento dei sindacati. A fronte di questi sviluppi deleteri, che rischiano di uccidere la democrazia, non c’è che una soluzione: fermare la globalizzazione, compresi i flussi migratori, e ristabilire la piena sovranità degli Stati nazionali. Tornare al ‘900, insomma. Restaurare il contenitore per stipulare trattati di pace fra le super-classi e gli strati subalterni: nuovi contratti sociali imperniati sui princìpi del pluralismo democratico e su agende sviluppiste, orientate a favorire gli interessi economici nazionali.
Quella di Lind è in larga misura una retrotopia, per usare il linguaggio di Zygmunt Bauman. Un progetto che guarda all’indietro, che vuole arginare il cambiamento ricostruendo le tribù nazionali e resuscitando neo-corporativismo e politiche economiche mercantiliste. Secondo Lind, saranno le stesse super-classi a promuovere questo ritorno al passato. Le convinceranno due paure: quella di insurrezioni dal basso, soprattutto da parte degli outsider, ma anche quella di uscire sconfitte nella grande competizione neoliberista fra blocchi economici regionali.
Che cosa sostiene e cosa propone invece l’orientamento ottimista? Una delle versioni più articolate è quella formulata da Torben Iversen e David Soskice nel volume “Democracy and Prosperity” (Princeton University Press). Secondo gli autori, la sfida della globalizzazione non va sopravvalutata, perché il sistema economico-politico ereditato dal ‘900 è capace strutturalmente di auto-correzione. La classe capitalista (quella che Lind chiama la super-classe dominante) è meno coesa di quanto sembri, proprio a causa delle pressioni competitive differenziate che provengono dall’integrazione dei mercati. Per avere successo nella nuova economia, le imprese devono poi essere sorrette da robusti retroterra di capitale umano, servizi di alta qualità, centri per la produzione di conoscenza e innovazione. Insomma, hanno bisogno di forti ancoraggi territoriali, e dunque dello Stato: non sono affatto libere di spostarsi quando vogliono alla rincorsa di costi del lavoro più bassi e contesti regolativi più leggeri. Il loro interesse è anzi quello di promuovere e cofinanziare politiche pubbliche che ammortizzino i cambiamenti sociali, favoriscano la formazione di una forza lavoro qualificata, stimolino ricerca e innovazione.
Se gestite bene, l’apertura dei mercati e le nuove tecnologie possono assicurare prosperità e buona occupazione per tutti. Una democrazia funzionante deve impegnarsi a realizzare questi obiettivi, dai quali dipendono la pace sociale e il consenso politico e dunque la stessa sopravvivenza della democrazia. E’ vero che la povertà è aumentata. Ma a saper leggere i dati, il reddito delle classi medie ha in realtà continuato a restare allineato con i tassi di crescita. La seconda metà del ‘900 ha creato una vera simbiosi tra capitalismo, democrazia e Stato sociale. Oggi stiamo attraversando una fase di crisi, ma il sistema ha dentro di sé le capacità per resistere e riconfigurarsi.
Lo scenario tratteggiato da Iversen e Soskice è rassicurante e in fondo più plausibile di quello retrotopico di Lind. I grandi processi di cambiamento tendono sempre a generare questioni sociali e turbolenze politiche. Siccome la storia è caratterizzata da un certo grado di irreversibilità, è più saggio investire nel futuro e cercare equilibri più avanzati tra mercato, democrazia e welfare piuttosto che inseguire la restaurazione del passato. Iversen e Soskice sopravvalutano però la capacità di autocorrezione dell’attuale sistema. Per recuperare equilibrio c’è infatti da fare un gran lavoro.
La polarizzazione fra uno strato di pigliatutto e uno di piglianiente è una sfida reale e molto seria (su questo Lind ha ragione). I ceti dominanti hanno sempre consolidato la propria posizione monopolizzando il controllo sulle varie possibilità acquisitive (incrementi di opportunità e ricchezza) all’interno della società. La seconda grande trasformazione che stiamo vivendo oggi ha minato le fondamenta statali-nazionali dei compromessi di classe novecenteschi, scaturiti come risposta alla prima grande trasformazione (quella industriale) così ben descritta da Karl Polanyi. L’immagine di una società basata sulla conoscenza, con imprese benevole e servizi di qualità, opportunità diffuse di istruzione e formazione è accattivante. E forse esiste già in qualche isola fortunata dell’Europa del Nord o della California. Ma il percorso per arrivarci davvero è lungo e faticoso.
Due sono i fronti principali su cui impegnarsi. Il primo è quello di proteggere gli strati sociali perdenti, di sottrarre il Quinto Stato alle morse della precarietà e del bisogno. E’ l’agenda del nuovo welfare, fatto di tutele attive, ma anche di massicci investimenti sociali. Questa agenda è ancora incompiuta, e dovrebbe essere una priorità dei Piani nazionali di ripresa e di resilienza che i governi dell’U.E. stanno preparando in questi mesi. Il secondo fronte è la rimozione dei troppi colli di bottiglia che ostacolano la mobilità sociale. La famiglia di nascita è ancora il principale veicolo di trasmissione intergenerazionale di vantaggi e svantaggi. Le dinamiche di globalizzazione hanno fortemente accresciuto l’importanza della località di nascita e di crescita. Non a caso sia Lind sia Iversen e Soskice parlano di un divario crescente fra metropoli e provincia, fra centri e periferie territoriali. Servono politiche deliberate di promozione della mobilità, che tengano conto delle diverse situazioni territoriali.
Gli effetti economici e sociali della pandemia in corso rendono il percorso più difficile. Ed è probabile che il cosiddetto ritorno alla normalità dopo la sconfitta del virus apra una nuova stagione di conflitti redistributivi. Ma non sarà una guerra di classe. La pandemia ha cambiato l’agenda e la stessa cultura dei governi. In Europa il neoliberismo tecnocratico è stato scalfito in alcuni dei suoi pilastri portanti (pensiamo alla sospensione del patto di stabilità o al debito comune per finanziare il piano Next Generation Eu) e sta evolvendo verso un modello di liberalismo sociale più attento alle istanze dei cittadini e più rispettoso di quel pluralismo democratico di cui parla Lind. In fondo al tunnel s’intravedono i contorni di quegli equilibri più avanzati fra capitalismo, democrazia e welfare verso cui tendere, abbandonando le nostalgie retrotopiche.
Alla fine del suo libro “La grande trasformazione” Karl Polanyi sosteneva: “La restaurazione del passato è impossibile, tanto quanto trasferire i nostri problemi su un altro pianeta”. E poco dopo aggiungeva: “D’altra parte il collasso del sistema tradizionale non ci lascia sospesi nel vuoto; anzi la società industriale può permettersi di essere al tempo stesso giusta e libera”. Questa affermazione vale anche per la società post-industriale e globalizzata di questo nuovo secolo. Ma si tratta di un futuro possibile, non di una evoluzione necessaria. Che dipende in ultima analisi dalle opzioni di valore, dalle capacità di leadership, dalle scelte concrete di chi occupa ruoli di responsabilità nella sfera economica, sociale e soprattutto politica.
Maurizio Ferrera