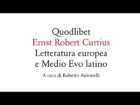La voce restituita a Clitennestra
Viene dall’autrice riletta una figura del mondo classico vedendone la forza e lo slancio di emancipazione.
Ne “La Lettura” del 14 maggio 2023, supplemento culturale del Corriere della Sera, è pubblicato questo interessante articolo-intervista di Costanza Rizzacasa D’Orsogna a Costanza Casati.
“Mi hanno chiamata madre e regina, mostro e assassina. Questa è la mia storia. Di come il mio grande amore e il mio bambino siano stati uccisi da Agamennone. E di come i semi della vendetta impieghino anni per far crescere i loro frutti amari. Perché gli uomini vogliono rendere le donne invisibili. Distruggendole. E facendo dimenticare loro di essere più forti degli uomini, e perfino degli dèi”. Scrive così Costanza Casati, 27 anni, all’esordio narrativo con “Clitennestra”, il retelling di una delle figure più complesse e carismatiche del mito greco, appena sbarcato negli Usa dopo il grande successo in Gran Bretagna, e in uscita in Italia il 23 maggio per Sperling & Kupfer. Una rilettura che si inserisce in un filone molto fortunato, quello di riscoprire i classici alla luce di nuove sensibilità, ma che esplora con grande efficacia temi come la rabbia, il potere e l’ambizione femminile.
Nata in Texas nel 1995, Casati ha studiato in Italia al liceo classico, e perfezionato gli studi di letteratura inglese e scrittura creativa tra Londra, Oxford, Cambridge e l’Università della California.
Perché proprio Clitennestra?
La mia ossessione è iniziata oltre dieci anni fa, mentre studiavo l’Orestea di Eschilo. Clitennestra, uno dei personaggi più odiati e diffamati della tradizione greca, mi ha conquistata subito. La prima volta che viene menzionata è nell’XI libro dell’Odissea, in un discorso del marito Agamennone, che Clitennestra ucciderà al ritorno dalla guerra di Troia per vendicare la morte della figlia Ifigenia. Lui la presenta come la sua sposa funesta, la definisce odiosa. “Quel perfido mostro”, dice, “ha coperto se stessa di infamia e tutte le donne in futuro. Anche se ce ne fossero di buone”. Ma Clitennestra non era così: era un personaggio affascinante nel racconto che Eschilo ne fa nell’”Agamennone”. Una regina: al potere non perché moglie di o figlia di. Uno degli aspetti che più colpiscono della personalità di Clitennestra è il suo fortissimo senso di sé. Lei non è interessata al giudizio della società, e questo è estremamente moderno perché nel mondo greco, al contrario, era proprio il giudizio del gruppo a dettare la personalità e i comportamenti. Da Fedra a Ettore, le azioni di moltissimi personaggi sono determinate dalla paura del giudizio sociale. Le due forze in campo erano la vergogna (aidòs) e l’onore o pubblica stima (timè), e tutti si muovevano tra queste due, cercando di evitare la vergogna e aspirando all’onore. Clitennestra non è interessata a tutto questo.
In che modo voleva raccontare il mito?
Cercando una chiave di lettura fresca e diversa che rimanesse però fedele ai testi antichi. Oggi si fa spesso l’errore di guardare ai classici della tragedia greca come a testi che le donne le diffamano soltanto. In realtà, se leggiamo ad esempio Euripide, le sue donne sono estremamente sfaccettate, ambiziose, eloquenti, carismatiche. Nel corso dei secoli una lente maschile e maschilista ha ridotto questi personaggi a stereotipi. Così le donne della tragedia greca sono o diffamate o senza voce propria, e i due più grandi esempi di ciò sono proprio Clitennestra e la cugina Penelope. La prima, prototipo della moglie infedele, arrabbiata e vendicativa, l’altra messa a tacere.
Penelope, cancellata due volte. Due anni fa un liceo americano aveva bandito l’”Odissea” perché, nel IX secolo a.C., promuoveva idee non conformi ai moderni codici di comportamento: Penelope che aspetta paziente per 20 anni il ritorno del marito, questa la critica, non è un modello femminista.
Nel primo libro dell’Odissea Penelope chiede all’aedo, che canta le gesta degli eroi che cercano di far ritorno a casa, di passare ad altro. Il figlio Telemaco la zittisce: “Taci, madre”, le dice. “torna ai tuoi appartamenti, alle tue cose da donna, alle tue tele da tessere. Perché il discorso pubblico (mytos) appartiene agli uomini”. Curiosamente, oggi siamo proprio noi autrici donne a rispolverare questi miti, riappropriandocene.
Un altro personaggio storicamente ridotto a cliché è Elena. Donna bellissima, quindi manipolatrice, e superficiale.
Elena, sorella di Clitennestra, è una delle donne meno comprese della tradizione greca: per scriverne ho dovuto superare millenni di diffamazione ai suoi danni. Se leggiamo Euripide, è invece un personaggio molto complesso. Crediamo che fosse estremamente invidiata per la sua bellezza, ma Elena era cresciuta a Sparta, dove la bellezza non era così importante. C’è un episodio, in particolare, ne “Le troiane”, in cui Ecuba, ex regina di Troia, dice a Menelao di sbarazzarsi di Elena, perché “dovunque tua moglie guardi porta morte e distruzione”. Menelao si reca allora da Elena per ucciderla, ma quella lo ferma con una lunghissima arringa difensiva in cui spiega come non sia stata lei a causare la guerra di Troia, e nel farlo è estremamente eloquente e arguta. La stessa eloquenza che ritroviamo nella Clitennestra dell’”Agamennone” di Eschilo. Donne che in una discussione hanno la meglio sugli uomini, che sono più intelligenti degli uomini.
Dicevamo della rabbia femminile. “Non c’è pace per una donna ambiziosa”, scrive alla prima riga del suo libro. “Se è troppo potente, è spietata. Se cerca vendetta, è pazza”.
Le donne arrabbiate sono le più odiate, anche quando la loro rabbia è pienamente giustificata, come nel caso di Clitennestra. L’idea moderna di eroismo, però, è assai diversa da quella dell’Età del bronzo. Per gli antichi greci l’eroe non era una brava persona: era spietato, arrogante, senza scrupoli. Proprio come Agamennone. Nel mio romanzo esploro questo concetto applicandolo ai personaggi femminili. Un altro aspetto su cui volevo indagare è il potere femminile, che a noi sembra una conquista recente, ma in realtà è sempre esistito. Per tutti i progressi che ha fatto la nostra società, però, non riusciamo ancora ad apprezzare una donna al potere. Dobbiamo sempre trovarle dei difetti, sminuirla: la giudichiamo col metro della simpatia. Invece è fondamentale andare al di là della simpatia quando si scrivono personaggi femminili. A Clitennestra non interessava affatto piacere. Ella sa che in quanto donna di potere non potrà essere amata. Ma vuole essere rispettata. Quel rispetto che per Agamennone è scontato, perché lui è re, lei se l’è conquistato. All’inizio dell’”Agamennone” il coro di anziani consiglieri le dice: “Clitennestra, rispettiamo il tuo potere”. Ecco, mi interessava capire che cosa avesse dovuto sacrificare Clitennestra per ottenere quel rispetto. Allo stesso tempo era fondamentale per me avere un cast di personaggi maschili sfaccettati, perché il rischio di un retelling femminista è fare lo stesso errore che è stato fatto per secoli nei confronti delle donne, cioè ridurle a figurine stereotipate.
Costanza Rizzacasa D’Orsogna Costanza Casati