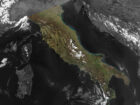L’urlo di protesta della cultura russa
Non c’è Paese europeo che più della Russia –prima zarista, poi sovietica, ora putiniana- abbia subìto repressioni culturali tanto violente: censure, esilio, fucilazioni, suicidi.
Imbavagliata, censurata, perseguitata, la cultura russa non ha mai smesso di dire no al potere. E il potere, dal Paleolitico in poi, di qualsiasi colore esso sia, vuole sempre la stessa cosa: o consenso o silenzio. Tra tutti i Paesi europei la Russia è certamente quello che ha pagato il prezzo più alto in fatto di vittime della repressione culturale: la sua storia è costellata di capi dispotici che hanno fatto tacere con la violenza ogni dissenso.
Comincia Caterina II la Grande a fine ‘700: prima corteggia e finanzia gli enciclopedisti francesi, apre le sue regge a Voltaire e Diderot, poi, quando si accorge che l’Illuminismo porta dritto alla rivoluzione e alla ghigliottina, alza la prima (forse) cortina di ferro e mette in galera liberi pensatori, oppositori, dissidenti. Non fa meglio il suo nipotino Alessandro I: sconfigge, è vero, Napoleone e libera l’Europa da un tiranno, ma troppo tardi si accorge che i suoi ufficiali, mentre brindano alla vittoria per le strade di Parigi, respirano a pieni polmoni l’aria pericolosa dei giacobini e dei girondini. Infatti, ritornati in patria, gli preparano la prima vera (e unica) rivoluzione dell’Ottocento russo: quella dei decabristi. Nel dicembre 1825 un manipolo di alti ufficiali e aristocratici scende in piazza (quella del Palazzo d’Inverno) e grida: abbasso l’autocrazia, evviva la costituzione. Immediata, inflessibile repressione: tra i rivoltosi chi evita il patibolo viene condannato a esilio perpetuo nella lontana Siberia.
Dopo quel fatidico dicembre Nicola I, il successore, fa scendere una cappa di piombo: per 30 anni in Russia non si respira più. Polizia, spie, delatori, comitati di controllo, la famigerata Terza sezione che passa al vaglio le virgole.
Puskin è un sorvegliato speciale: non c’è riga, non c’è verso che non venga sezionato, scandagliato, soppesato, il suo Boris Godunov deve aspettare trent’anni per andare in scena e il suo Evgenij Onegin viene decurtato di un intero capitolo. Gogol’ non fa eccezione, scompare un lungo episodio di Anime morte; e Dostoevskij, giovane promessa della nuova prosa, finisce sul patibolo (poi graziato, va comunque ai lavori forzati) per avere alzato la voce, in un circolo di amici, contro la censura.
Nemmeno con il nuovo zar, Alessandro II, che pure avvia, con estrema lentezza e scarsa intelligenza, qualche indispensabile riforma (per esempio l’abolizione della servitù della gleba: la Russia è l’ultimo Paese europeo ad avere una forma di schiavitù legalizzata), la censura allenta la morsa: Turgenev si vede contestare Padri e figli perché parla con troppo fervore dei nichilisti (anche se il suo Bazarov muore nel finale senza gloria), Dostoevskij deve fare a meno di un intero capitolo dei Demoni, a Tolstoj bocciano l’epilogo di Anna Karenina perché parla in modo improprio della guerra russo-turca. Con lui si accanisce anche la Chiesa ortodossa che disapprova la sua concezione libera del cristianesimo e, con una clamorosa scomunica, si allea con gli sbirri zaristi. Eppure durante il grandioso trentennio che va dal 1850 al 1880, in cui la prosa russa raggiunge il suo acme, mai gli scrittori smettono, seppure con la cautela suggerita dalla necessità di evitare gli scogli censori, di fare sentire la loro voce di protesta, la voglia di libertà, la convinzione che solo in una società tollerante può vivere l’uomo.
La Rivoluzione del 1917 sembra per un attimo realizzare il sogno di tutti: via la censura, via il controllo, via i tronfi burocrati zaristi con i loro drastici net. Ma è un attimo. Anche i bolscevichi non si smentiscono, vogliono quello che tutti i poteri forti vogliono: consenso. Già nel 1920 partono le prime repressioni: e Nikolaj Gumilev, marito di Anna Achmatova, finisce davanti al plotone d’esecuzione perché contrario alla dittatura del proletariato. Due anni dopo i principali pensatori, filosofi, studiosi non allineati vengono presi, caricati su una nave e spediti in Occidente, perché non disturbino la libera affermazione del nuovo regime. Majakovskij è il vate conclamato della poesia rivoluzionaria, fino a che non si accorge che dalle ceneri dello zarismo rinasce ben presto un’altrettanto intollerante, se non peggiore, generazione di supervisori che, con accanimento ancora più sadico, bloccano ogni voce di dissenso; la sua Cimice, il suo Bagno denunciano apertamente la nascita di un nuovo conformismo, più becero di quello tanto deprecato della borghesia pre-rivoluzionaria. Si spara un colpo alla tempia non certo per una bella donna: perché gli manca l’aria, si sente in trappola. E in trappola è fin dagli esordi Michail Bulgakov, a cui censurano l’ultima parte del primo romanzo, La guardia bianca: non c’è che pubblicarlo all’estero. Non piacciono nemmeno i suoi racconti fantascientifici, da Cuore di cane a Uova fatali, dove affiora tutta la volgarità, l’ottusità dell’homo sovieticus: per sopravvivere finisce a fare l’aiuto regista al teatro di Stanislavskij e tiene rigorosamente nel cassetto il suo Maestro e Margherita, che solo i posteri scopriranno a vent’anni dalla sua morte.
Con il suicidio di Majakovskij inizia il lungo, atroce ventennio dello strapotere staliniano: nel tritacarne del dittatore finiscono tutti, poeti e romanzieri, pittori e registi, musicisti e scienziati. Impossibile la minima deviazione dalla linea del partito: viene tappata la bocca a chiunque osi denunciare le sempre più ampie fessure del regime. Una generazione massacrata. Una formidabile cultura schiacciata. Basta una frase,, un accenno, un’allusione ed è subito arresto, condanna, cancellazione, Siberia. Piuttosto che finire di fronte a un plotone d’esecuzione, come Babel’ e Mejerchol’d, o inghiottiti in un lager come Mandel’stam o appesi a un cappio come la Cvetaeva, meglio essere ridotti al silenzio, ostracizzati, cancellati come l’Achmatova che per trent’anni non riesce a pubblicare un solo verso o Pasternak che vive di traduzioni e di oscuri lavori redazionali.
Un giovane scrittore proletario, Vasilij Grossman, che tenta invano di pubblicare la sua magistrale saga sul conflitto mondiale, Vita e destino, ha il coraggio di dire: tra i lager staliniani e quelli hitleriani c’è la sola differenza che all’ingresso dei primi c’è la falce e il martello, dei secondi la croce uncinata. Ma le due violenze sono identiche.
La scomparsa di Stalin sembra un sollievo, ma per poco. Il veto categorico al Dottor Zivago ne è l’immediata dimostrazione: l’intera, assurda vicenda del romanzo, tra fuga all’estero del manoscritto (in Italia, grazie all’editore Feltrinelli, come si sa), irremovibile muro di tutti i partiti comunisti, compreso quello italiano, il Nobel rifiutato fanno capire che ben poco è cambiato. E se per la distrazione di un poco solerte censore esce sulla rivista “Novyj mir” un romanzo breve, Una giornata di Ivan Denisovic, dove per la prima volta si parla apertamente di lager, l’attivissimo apparato censorio subito interviene, tappa immediatamente la bocca al suo autore Solzenicyn, e i suoi successivi romanzi, da Divisione cancro al Primo cerchio escono solo all’estero. Anche i poeti continuano a essere scomodi: Krusciov nel 1964 fa arrestare Josif Brodskij, giovane allievo di Anna Achmatova, perché poeta, cioè nullafacente, e Breznev lo caccia dal Paese, togliendogli per sempre la cittadinanza. Scrivere versi in Unione Sovietica non è una professione ammessa.
Crolla l’Urss. Cambiano le cose? Di poco: l’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja nel 2006 insegna. Scrivere, ma anche filmare, dipingere, mettere in scena, in modo libero, in Russia continua a essere pericoloso.
Stupisce che perfino da noi si ritenga inopportuno parlare di uno scrittore russo come Dostoevskij che è salito sul patibolo per dire no al potere. Inopportuno? Direi più opportuno che mai. Nessuna cultura ha avuto tanto coraggio, come la cultura russa, di opporsi ai tiranni, ai diktat, ai bavagli.
Fausto Malcovati
Questo articolo è stato pubblicato ne “La Lettura”, inserto culturale del Corriere della Sera del 13 marzo 2022, a pag. 7. Un serio commento alla crudele e feroce aggressione russa alla vicina e sorella Ucraina.