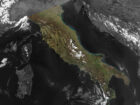“Nella fabbrica della politica”. Note a margine del saggio di M. Revelli, “Finale di partito”, Einaudi. Articolo di Gigi Riva.
Nel numero de “L’Espresso” del 21 marzo 2013 è stato pubblicato un articolo di commento di Gigi Riva a un interessantissimo saggio di M. Revelli, “Finale di partito”. Ho deciso di pubblicarlo perché ci è di aiuto nell’orientarci sulla situazione politica e sociale italiana dopo le elezioni del 24-25 febbraio. Voglio anche ricordare che –nello stesso periodo- è stato pubblicato un saggio di Salvatore Lupo, “Antipartiti”, Donzelli editore, ideale prosecuzione di un suo altro libro, “Partito e antipartito”, che si fermava all’uccisione di Moro, la cui tesi di fondo è che –più che distruggere i partiti- sia necessario rifondarli daccapo.
Probabilmente stiamo assistendo ad un terremoto dal quale uscirà una società politica radicalmente diversa da quella attuale, qualcosa di simile a quanto accadde con la Riforma luterana quando si scoprì che si poteva celebrare il rapporto tra l’uomo e la divinità senza la mediazione della Chiesa. Allora fu la stampa a favorire il processo, oggi ci sarebbe la Rete. Bisogna dire addio alla “politica delle masse” tipica dell’esperienza novecentesca? Attenti, però: la Rete, da sola, non è democrazia. Questa ha bisogno di essere discussa, dibattuta. Per confrontarsi bisogna incontrarsi. On line, anche, ma non solo. La cittadinanza è un’abilità che s’impara, esercitandola. E non certo su Facebook: il “like” o il commento anonimo sono il contrario del gesto democratico, servono a evitare di agire. Partecipare non significa inondare di lamenti o di critiche il sito di un candidato; significa mettersi in gioco per risolvere i problemi della propria comunità. Insomma, la democrazia non è la somma di una serie di petizioni affastellate l’una sull’altra. E’ un disegno strategico. Le decisioni per l’Italia non si possono prendere cliccando sì o no a un quesito. Bisogna avere una visione globale.
Ci sono molte ragioni storiche che spiegano la crisi dei partiti tradizionali, prima fra tutte quella che lega il loro processo d’impianto alla nascita dei grandi sistemi produttivi affermatisi nella seconda rivoluzione industriale di fine Ottocento, come spiega Revelli. L’intreccio genetico tra partiti di massa, produzione di massa, consumi di massa, mezzi di comunicazione di massa –che ha alimentato l’intera politica del Novecento- si è dissolto col tramonto delle ciminiere e la cancellazione dei paesaggi industriali dell’economia globalizzata. Dalla carta stampata alla televisione, dalla televisione al Web il cambiamento delle forme della comunicazione ha cambiato anche le forme dell’organizzazione della politica. Ma, per paradosso, sia il partito televisivo e aziendale di Berlusconi sia quello del web di Grillo propongono un populismo aggressivo che riprende molti tratti di quello novecentesco: un nemico assoluto contro cui combattere, un agglomerato eterogeneo di soggetti sociali come elettorato, l’irrilevanza di una classe politica (i “cittadini” di Grillo, i cortigiani servili di Berlusconi, la costellazione di feudi vogliosi di potere del partito democratico) schiacciata dal peso prorompente del dominio delle oligarchie e delle corporazioni strutturate..
Dopo il triplice suicidio di Civitanova Marche del marzo scorso un gruppo di persone furenti ha contestato la presidente della Camera, Laura Boldrini. Michele Serra in un suo articolo ha commentato: “Stato strozzino, assassino, inetto, partiti farabutti, politici schifosi, questo è l’umore della crisi, travolge ogni analisi, ogni discussione. Si tratta dello stesso Stato al quale, per generazioni, milioni di italiani hanno chiesto assunzioni, favori, esenzioni, protezione, assistenzialismo, e una lasca applicazione delle leggi, perché abusivismo ed evasione sono stati la generosa mancia che uno Stato piacione ha elargito a piene mani per decenni in cambio di voti. Quello Stato blandito come un padrino e questo, coperto di sputi, sono il rovescio della stessa medaglia: una comunità nazionale incapace, se non in cerchie ristrette e vanamente virtuose, di avere con il potere un rapporto adulto. Se siamo un popolo che, allo Stato, o bacia la mano o gliela morde, è perché siamo tragicamente incapaci di guardarci dentro, farci un esame di coscienza, prenderci le nostre responsabilità individuali e collettive. Lo Stato ci faceva comodo prima, come tetta da spremere, ci fa comodo oggi, come tiranno da impiccare” (Repubblica).
Voglio ricordare un episodio di molti anni fa. Erano i primi di dicembre del 1980, mi trovavo ad Angri, in provincia di Salerno, all’indomani del terribile terremoto dell’Irpinia. Consigliere comunale a Venezia, ero stato delegato dal sindaco della città lagunare a guidare una spedizione di soccorso del Comune e della provincia di Venezia. Ero in compagnia del sindaco della città campana quando vennero a parlargli due cittadini: chiedevano aiuto, supplicavano, baciavano le mani; non esigevano diritti, imploravano favori. Non erano cittadini che –consapevoli dei loro diritti e doveri- chiedevano ai responsabili dell’Amministrazione di far fronte agli eventi e di provvedere anche ai loro bisogni elementari; erano invece, in grande maggioranza, persone che si rivolgevano come clienti ai loro patroni e chiedevano, privatisticamente, favori e concessioni. Io ero abituato a una pratica politica e civile diversa, a trattare con cittadini organizzati e responsabili. Sapevo che la zona nocerina aveva vissuto esperienze sindacali e politiche importanti, testimonianze e presenze di coscienza seria e matura fin dai primi anni del Novecento. Ne deducevo che un costume di quel tipo –se generalizzato- avrebbe prodotto, a cascata, distorsioni gravi nell’uso del denaro pubblico che sarebbe servito per la ricostruzione, avrebbe favorito e incoraggiato il clientelismo e l’abuso incontrollato delle risorse, per di più in un’area con pesanti infiltrazioni camorristiche, avrebbe finito con l’inquinare anche le pratiche del ceto politico di sinistra.
Oggi i movimenti che danno voce a chi protesta sono fuori dall’epicentro dei processi significativi, non incidono, sono irrilevanti. Per cambiare il mondo la protesta deve vincere il vizio della semplificazione: fare i conti con la complessità, favorire la nascita di leadership collettive serie. Faccio un esempio: la decrescita non può essere il “volemose bene”. In Italia stiamo decrescendo e non per nostra volontà. La conseguenza sono i fallimenti a catena, la disoccupazione, i suicidi. Bisogna diminuire gli sprechi ma per farlo occorre avere nuove capacità di gestione della tecnologia. Per meritare sviluppo da una società che ti dà meno ore di lavoro e più ricchezza devi avere una cultura, una ricerca, una politica, una cittadinanza, un’opinione pubblica e un’informazione all’altezza.
Gennaro Cucciniello
Nella fabbrica della politica dopo il voto del febbraio 2013
A dicembre 2012 Marco Revelli, 65 anni, docente di scienza della politica all’Università del Piemonte Orientale, nell’ultimare questo suo libro vaticinava: “Il Movimento 5 Stelle può arrivare al 25% dei voti”. Sappiamo com’è andata. La sua era una deduzione che teneva conto dello specifico italiano, certo, ma era ancorata a un concetto più solido e universale felicemente riassunto nel titolo del volume (“Finale di partito”) e frutto di un’intuizione: i partiti, come li abbiamo conosciuti, stanno esalando gli ultimi respiri perché erano organizzati come la fabbrica fordista o come la burocrazia weberiana. Sono stati decisivi nella modernità ma, esattamente come quel modello di lavoro, non hanno retto alla prova della post-modernità.
La macchina politica marciava al ritmo della catena di montaggio (nota l’autore: “come già ebbe a intuire Antonio Gramsci”), un sistema chiuso, razionale, onni-comprensivo, autosufficiente, figlio anch’esso della seconda rivoluzione industriale. Ha funzionato, benissimo, finché ha potuto gonfiarsi, abbassando i costi di produzione e allargando la sua base. Poi il mercato di riferimento si è saturato, il gigantismo ha ceduto il passo a una struttura dell’azienda più leggera (in principio fu il “metodo Toyota” che sostituiva il mito della quantità con quello della qualità). Contemporaneamente il modello statalista burocratico weberiano cedeva sotto il peso dei suoi costi esorbitanti e la spinta ideologica del reaganismo americano. I partiti, fratelli dei due sistemi, non potevano avere diverso destino. Il professore esemplifica: “La Fiat adesso è un guscio vuoto. Allo stesso modo i partiti di massa sono un guscio vuoto”. E il consenso, il prodotto che usciva dalle sezioni, aspettava il passaggio di un Grillo o chi per lui lo raccogliesse fuori dai cancelli di Mirafiori.
Come la fattura dei beni materiali non è più totalmente nella fabbrica ma parte si fa all’esterno quando non si delocalizza, così i partiti devono cercare fuori da sé quello che prima creavano in proprio, la fedeltà, l’identità. Revelli: “Sono diventati più famelici perché hanno bisogno di trovare sul mercato i propri clienti, investire in immagine e questo costa”. Non a caso nel lessico di settore sono entrati concetti come “offerta politica, marketing politico”. Nel 1960 John F. Kennedy aveva vinto contro R. Nixon investendo 9,7 milioni di dollari (contro 10,1 dell’avversario). Nelle ultime elezioni presidenziali Obama ne ha spesi 932 contro 1028. Ma quelli sono gli USA del fundraising tra i privati, si attiva in vista delle elezioni e non c’è la necessità di mantenere, in assenza di scadenze, una struttura elefantiaca. In Francia, Germania, Inghilterra il meccanismo è tenuto sotto controllo, ti rimborsano solo quello che spendi. “Mentre l’Italia è l’unico Paese al mondo in cui i rimborsi non devono essere rendicontati. Per questo nella dilatazione dei costi siamo la maglia nera” nota il professore. Nonostante un referendum che bocciò il finanziamento pubblico, i soldi ai partiti sono rientrati sotto la formula appunto dei rimborsi elettorali: 47 milioni € nel 1996, oltre 500 milioni nel 2008, solo dodici anni dopo. Di fatto noi abbiamo sommato il tradizionale finanziamento e le spese di scopo per un appuntamento alle urne “e senza che gli stessi segretari sappiano dove va a finire il denaro. Succede tutto “a loro insaputa” perché il rapporto tra la politica e il denaro non è mai stato oggetto di una vera riflessione”. Il mostro divora una montagna di quattrini in modo quasi inconsapevole mentre la gente non arriva alla fine del mese. Revelli chiosa: “L’unico paragone lo posso trovare con la Francia del 1789”. Quando poi al re tagliarono la testa.
E’ la crisi economica che accorcia l’agonia dei partiti di massa. “E non c’è istituzione, per sacra che sia, che si possa dire al riparo da un’erosione di credibilità. La campana suona anche per il sindacato, guarda caso un altro prodotto del fordismo, che sconta il suo anacronismo. Il che non è un buon motivo per rinunciare a un meccanismo di tutele. Ma se non ne costruiremo in fretta uno universalistico, che valga per tutti, anche le tutele più legittime verranno spazzate via”. La visione è molto marxiana. Sono decisivi i rapporti di produzione. L’economia presiede e determina la politica, cioè l’arte che dovrebbe imbrigliarla. Attenzione: l’economia, non la finanza. Proprio partendo da questa analisi e non solo dal fiuto dell’aria, Revelli aveva previsto il boom grillino. Resta da chiedersi cosa succede adesso. Se la cava con una battuta beckettiana: “Stiamo aspettando Godot”. I vecchi partiti sono come dei contenitori pieni di buchi che perdono liquido, cioè 12 milioni di elettori. Un terremoto, un fenomeno naturale avviato dagli strati profondi della società più che un semplice cambiamento. E non regge il monito tremendo di leader al tramonto: “Dicono “dopo di noi il diluvio” e intendono che senza partiti non ci può essere democrazia. Non è vero. In realtà la democrazia è nata prima dei partiti, non è un loro prodotto, nulla vieta, da un punto di vista teorico, di immaginarla dopo”.
Godot può essere la Rete? “Internet rende obsolete le vecchie macchine politiche come fossero fabbriche fordiste. Ma il fatto che decostruisca le antiche forme della rappresentanza non significa che offra l’alternativa. Tanto è vero che Grillo è stato l’unico ad andare nelle piazze, ha dato corpo a se stesso e a una folla molto reale. Lo pensavamo un ectoplasma virtuale, invece occupava San Giovanni costringendo Bersani in un teatro”. E comunque sia non potremo fare a meno della rappresentanza: “Bisogna solo capire con quali limiti. Finora è stata totalizzante perché i partiti avevano il monopolio del discorso pubblico. Non è più così. La delega varrà per alcune cose, non per tutte. Gli agenti del popolo non sono il popolo. Prevedo un ricorso più massiccio ai referendum. Quelli sui beni comuni come l’acqua avevano del resto indicato una strada. Su questioni che riguardano la nostra vita vorremmo decidere noi”.
Si illude chi crede che deve solo “passare la nottata” perché i muri della casa sono ancora in piedi. E Revelli pensa al PD, visto che il PDL “è una casa finta”. Un’irruzione come quella a cui abbiamo assistito “non ha precedenti nella storia”. Indietro non si torna. Il professore confessa di oscillare tra due sentimenti: “Paura degli scenari ed euforia liberatoria perché finalmente il castello di carte è crollato come era inevitabile”. E noi, per parafrasare Montale, in questa fase possiamo solo sapere quello che non siamo più, quello che non vogliamo più.
Gigi Riva