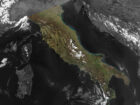Ho scardinato i confini d’Europa
Forse l’Europa è il sogno di chi non ce l’ha. I monaci benedettini la rilanciarono nel momento peggiore, con l’impero romano in macerie e sotto l’urto delle invasioni barbariche.
Questo articolo, pubblicato nel “Robinson di Repubblica” del 17 febbraio 2019, alle pp. 2-5, è stato scritto da Paolo Rumiz. Queste bellissime riflessioni sono state scritte quasi tre anni fa, ma sono attualissime oggi alla luce dei terribili avvenimenti alla frontiera tra Bielorussia e Polonia.
Gennaro Cucciniello
L’Europa la incontri anche lontano, dove meno te l’aspetti. Una greca, a Rodi, mi disse un giorno che Europa è un’idea, qualcosa che sta ovunque e in nessun luogo. Forse è il sogno di chi non ce l’ha. I monaci benedettini la rilanciarono nel momento peggiore, con l’impero romano in macerie e sotto l’urto delle invasioni barbariche. I padri fondatori dell’Unione la concepirono negli anni senza speranza del nazi-fascismo. Il mio stesso europeismo è nato dalla disperazione: quella per la rinascita dei nazionalismi e il letargo di Bruxelles. Non parliamo dei disperati in attesa d’imbarco sulla battigia del Nord Africa: guardano Europa con un desiderio di cui è incapace il nostro mondo sfinito dal consumo. Le parole più commoventi su questa mia terra le ho sentite da una vecchia contadina ucraina, commossa davanti al mare di grano pettinato dal vento sulle sponde del Dnestr. Mi aveva preso per mano per dirmi: “Guarda quanta ricchezza, potrebbe nutrire tutta l’Europa”. Nella sua bocca sdentata il mitico trisillabo aveva una dolcezza sconosciuta in Occidente.
Europa non abita nei centri ma nelle periferie, nelle banlieue dimenticate, sulle frontiere. Nelle osterie del Donegal, sulle coste tempestose d’Irlanda. Nell’isola di Gavdos, solitaria, persa nel mare Libico. A Narva, in Estonia, sul confine russo battuto dal vento del Baltico. Persino a Bruxelles Europa è un elemento centrifugo. Giorni fa, una domenica di pioggia, vi sono arrivato in treno e la città era paralizzata da un corteo di settantamila giovani che protestavano contro l’indifferenza della politica sul cambiamento climatico.
Spesso bisogna starne lontani per capire. Doversi blindare in casa la sera a Caracas perché fuori si spara. Tremare di fronte a una pattuglia della polizia in Messico. Vivere a Istanbul asserragliati in quartieri per ricchi chiusi da muri invalicabili. Perdersi per vie di New York che non hanno nomi ma solo numeri per distinguerle. Attraversare un paese come la Cina dove per quattro fusi orari la gente mangia l’identica ciotola di riso. Viaggiare per tre giorni in treno in Australia vedendo fuori dal finestrino sempre lo stesso deserto. Rischiare di farsi lapidare da orde di bambini mentre attraversi a piedi un villaggio etiope, o non trovare niente da mangiare per mille chilometri sulle strade del Sud Sudan. Perdersi nelle feroci bidonville di Rio de Janeiro. Allora capisci cos’è l’Europa. E ti accorgi di quanto sono pazzi quelli che la vorrebbero smantellare.
Un giorno il più grande dei miei nipotini –Chicco, sei anni- mi ha chiesto a bruciapelo cosa vuol dire “Europa”. Gli ho risposto che è la terra che ci nutre, un po’ come una mamma. Gli ho disegnato una mappa con fiumi e montagne e spiegato che quella è solo la parte finale di un continente più grande, l’Asia, e che siccome tra i due mondi non esiste confine, qui arrivano da sempre popoli a piedi o a cavallo in cerca di spazio. Popoli che però sono costretti a fermarsi qui, perché oltre c’è solo l’oceano. Ma i bimbi sono svegli, e così arriva la domanda su come fanno a starci tutti quei popoli nella piccola Europa. Gli rispondo che non hanno scelta. Devono solo capire se vivere in pace o ammazzarsi fra loro. Per questo abbiamo avuto momenti di pace ma anche tante guerre. Guerre tremende che hanno sterminato anche vecchi, donne e bambini. Dunque bisogna fare attenzione, perché la guerra è una cosa orrenda e può tornare in qualsiasi momento (…) Lui resta in silenzio, a testa bassa. E allora gli dico: questo non deve succedere. Ecco perché tu dovrai difendere la terra dei popoli dai malvagi che vogliono la guerra.
Raccontare ai bambini serve a chiarirsi le idee. Ti scopri a dire cose cui non avevi pensato. Che l’Europa è un gran bel posto, dove non si muore di freddo né di caldo. Uno spazio temperato, fertile, verde, pieno di foreste, fiumi, montagne e antiche bellissime città. Una ricchezza che tutti ci invidiano, perché altrove hai spesso deserti, steppe, ghiacci, siccità. In Europa hai anche la democrazia, che è quella cosa che protegge i deboli e li difende dalla violenza dei malvagi. In tante parti del mondo non succede. Puoi essere ucciso per la strada, messo in prigione per nulla. L’Europa è circondata da nemici. E’ un piccolo paradiso che dà fastidio a tanti. E se faccio un bell’elenco delle minacce che ci circondano –il clima che cambia, i fanatici che uccidono in nome di Dio, i mercanti d’armi, i razzisti, i prepotenti che ignorano le regole e vorrebbero completare senza ostacoli il saccheggio del pianeta- ecco che quando chiedo al nipotino se di fronte a questi pericoli è giusto stare uniti o separati, lui non esita un attimo. Risponde: “Tutti uniti”.
Europa, dico, è poter camminare da soli di notte senza timore di essere aggrediti, non solo perché c’è la polizia, ma perché regna la pace sociale. Europa è l’agorà, la piazza come luogo d’incontro dove puoi goderti il fresco della sera senza dover consumare. Europa sono le città dove miseria e nobiltà si mescolano liberamente, come a Napoli, Torino, Marsiglia, Londra. Europa è paesaggio umanizzato, percorribile, vecchi ponti in piedi da duemila anni, è sfiato di alambicchi, caffè con i giornali a disposizione, reticolo di strade e sentieri millenari, chiese romaniche, guglie gotiche perse nei campi di grano, antiche forge e sonnolenti canali. E’ il santo perimetro dei monasteri e delle abbazie. Europa è una terra dove gli dèi e i mercanti si incontrano, spesso sulle sponde dello stesso mare. La terra delle diversità, dove basta cambiare valle per sentire un’altra parlata e mangiare un pane differente. Un mondo aperto, per demolire il quale lavorano senza sosta i falsi profeti, che siano ministri della paura, partigiani del cemento inutile, distruttori di panchine (…)
Quanti incontri straordinari ho fatto nei miei viaggi tra Atlantico e Urali. Volti riemergono a distanza di anni. Antonio e Giuseppe, contadini di Gomorra che, vedendomi camminare con un caldo bestiale, mi chiamano dicendo: “Signò, assettateve nu poco, qui c’è nu pozzo cu l’acqua fresca”. Un prete russo di nome Leonid, che in una notte bianca mi accoglie nella sua canonica in mezzo alla tundra. O Alejandra, bionda castigliana, che mi mostra la luna sulla Sierra de Guadarrama. Mi chiedo spesso che ne è di loro. Dov’è finito Atanassios, greco di anima e corpo, che mi ha regalato un sorriso e gamberi pescati in una baia delle Cicladi. Mauro, pastore del Molise, che mi ha congedato nella pioggia col più regale dei saluti: “T’accumpagno c’o pensiero”. O Anatolij Fedorovic, che spremeva malinconia da un’armonica per belle ragazze dalle labbra di lampone, mentre sul Lago Onega le foreste prendevano il colore dell’ambra.
Europa sono le persone più ancora dei luoghi. Un giorno, nella Francia profonda, mi capita di bussare senza preavviso alla porta semiaperta di un amico contadino che non vedo da vent’anni. E’ intento a farsi una zuppa di cipolle. L’odore non lascia dubbi. Senza girarsi e mostrare reazione alcuna, chiede: “Vous etes combien?” –quanti siete- e quando rispondo “due”, butta altra cipolla a tostare nel tegame, fa rudemente posto col dorso della mano sul tavolaccio ingombro di roba, vi posa due piatti e solo a quel punto si volta e viene sulla soglia ad abbracciarci. In lui era la Francia immortale, ma, dietro di lui, l’Europa.
Ma in nessun luogo come in Appennino –la patria di Benedetto, patrono d’Europa- sento la mia terra-madre nella sua perfetta femminilità. Di sera soprattutto, quando attaccano i grilli e l’incendio del tramonto si spegne con infinita lentezza nelle gole e sui colli punteggiati di eremi medievali. A quell’ora tutto torna: la luce, il ticchettio del tempo, la devozione dell’ascolto, l’epopea di un continente sospeso tra l’oceano e l’urto dei popoli, le linee tremende di faglia e le paure che le percorrono. Ma soprattutto l’infinito senso di pace emanato da una terra che pure l’aratro di Dio sconvolge di continuo. So perfettamente da dove scaturisce l’infinita dolcezza di quel paesaggio fratturato in perenne sommovimento. E’ la mano dell’uomo che ha addomesticato la Bestia. Lo leggi nello sfalcio dei pendii, nei terrazzamenti, nelle vigne, nei paesi arroccati, nelle greggi al pascolo, nel profumo del pane, nelle litanie cantate dei monasteri, nella bontà del vino, nella centralità della mensa e nel ritmo rotondo delle parlate.
Una terra a misura d’uomo, misurabile e percorribile, dove è quasi impossibile distinguere ciò che è stato fatto dalla mano di Dio e ciò che è frutto della fatica delle genti. Ecco, questo per me è Europa.
Paolo Rumiz