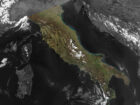Populista o riformatore. I volti di papa Bergoglio.
Un saggio di Loris Zanatta è polemico verso papa Francesco. L’autore ne discute con due studiosi del cattolicesimo, Luca Diotallevi e Daniele Menozzi.
Coordina il dibattito Antonio Carioti ne “La Lettura” del 23 febbraio 2025, alle pagine 41-43.
I cattolici sono in ansia per la salute di papa Francesco, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Ma non cessano per questo le discussioni sul suo magistero. Per esempio Loris Zanatta, docente di Storia dell’America latina all’Università di Bologna, nel libro “Bergoglio. Una biografia politica” (Laterza), avanza forti riserve sulle posizioni del Papa da un punto di vista laico e liberale. A suo avviso la rivoluzione di Francesco è in realtà un salto indietro verso una Chiesa antimoderna, ispirato dalla cultura peronista argentina. Per approfondire la questione abbiamo chiamato Zanatta a discutere con Luca Diotallevi, professore di Sociologia all’Università di Roma Tre, e con Daniele Menozzi, docente emerito di Storia contemporanea alla Normale di Pisa.
DIOTALLEVI. Tra le reazioni del cattolicesimo alla modernità possiamo distinguere quattro posizioni. Ci sono quella intransigente antimoderna e quella modernista, di orientamento opposto. Poi c’è l’intransigentismo moderato di chi tenta di combattere la modernità con i suoi stessi strumenti. E infine c’è chi vede nel mondo moderno non soltanto rischi, ma anche opportunità positive, come pensavano Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni. La posizione di papa Francesco va ricondotta al terzo indirizzo: una lotta alla modernità, condotta con le armi della modernità stessa, che ha effetti non voluti di contributo alla modernizzazione. Così ha agito appunto in Argentina il regime di Juan Domingo Peròn, ostile alla modernità, ma incline a utilizzarne gli strumenti, come i mass media e i sindacati.
Come si colloca in questo quadro il Concilio Vaticano II?
DIOTALLEVI. In quella sede prevale la linea di Paolo VI, che vede nella modernità un’occasione positiva. I suoi tre successori più rilevanti sono però espressione di realtà in cui le ragioni nazionali fungono da freno alla modernizzazione: la Polonia per Giovanni Paolo II; la Baviera per Benedetto XVI; l’Argentina nel caso di Francesco. Con loro nella Chiesa postmontiniana torna l’intransigentismo moderato che intende mettere le briglie alla modernità. Tuttavia, mentre Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger accolgono l’istanza dei diritti e della libertà personale, Bergoglio ha un’impostazione assai più comunitarista, fondata sull’aspirazione all’armonia sociale e sul mito del popolo cattolico. Una visione coltivata da una parte della Compagnia di Gesù, come sottolinea Zanatta, ma diversa da quella di gesuiti aperti al dialogo con la modernità come Henri-Marie de Lubac, Karl Rahner, John Courtney e Carlo Maria Martini.
MENOZZI. Zanatta identifica la modernità con la rivendicazione di indipendenza del singolo dalla tutela dell’autorità ecclesiastica. Il Vaticano II fece i conti con questo fenomeno, ma sulle modalità del necessario dialogo col mondo moderno non c’era accordo. La maggioranza dei padri conciliari voleva costruire una cristianità ammodernata: una società diversa da quella sacralizzata del passato, disposta a riconoscere la libertà religiosa, ma non la piena autonomia dell’individuo rispetto alla legge naturale di cui la Chiesa è depositaria. Una linea minoritaria era quella che riconduceva lo scontro con il mondo moderno a letture della Sacra Scrittura storicamente condizionate, le cui incrostazioni avevano impedito un dialogo costruttivo: si trattava dunque di cogliere i segni dei tempi per fare emergere un’intelligenza del Vangelo capace di promuovere valori come la pace e la fratellanza universale.
Quale posizione ha prevalso?
MENOZZI. I Papi postconciliari, da Paolo VI a Benedetto XVI, hanno perseguito, con diverse declinazioni, l’obiettivo della cristianità ammodernata. Ma nel frattempo l’allontanamento dell’uomo moderno dalla Chiesa non si è ridotto, come voleva il Concilio, ma si è accentuato. Papa Francesco segna un ritorno alla linea minoritaria del Vaticano II: un’immersione nella storia attraverso cui la Chiesa spera di acquistare una migliore comprensione del Vangelo per proporre agli uomini l’incontro con la fede su un terreno comune di valori.
Francesco ha dismesso la visione comunitaria di marca peronista?
MENOZZI. Qualunque sia stata la posizione di Bergoglio prima dell’accesso al pontificato, una volta diventato Papa egli ha deciso di abbandonare il rapporto con la modernità intrapreso dai predecessori, che si era rivelato sterile. La sua posizione non è un salto indietro, ma un ritorno al Vaticano II nella ricerca di una strada per consentire alla Chiesa di svolgere un’azione pastorale efficace.
ZANATTA. Io ho analizzato l’opera e il pensiero di Papa Francesco da una prospettiva laica, che parte dalla storia peculiare della Chiesa argentina, da cui è scaturita una cultura cattolica ben radicata e fusa con il mito nazionale. Dio e Patria si sono combinati nel progetto di restaurare un ordine pervaso di religiosità. E non vedo un distacco di Francesco da questa linea: nel pontificato leggo una proiezione su scala globale della sua esperienza nazionale. D’altronde fino a 76 anni è stato portatore di quella visione e non poteva distaccarsene d’un tratto.
Approfondiamo il suo rapporto con il regime di Peròn.
ZANATTA. Il peronismo è stato il braccio secolare del mito nazional-cattolico argentino. E non si è mai considerato un partito come gli altri, bensì il rappresentante di tutto il Paese. Il suo nemico giurato era e rimane il liberalismo, considerato il frutto del razionalismo illuminista, a sua volta un effetto, magari indesiderato, della Riforma protestante. Bergoglio si è riconosciuto nella visione del peronismo come movimento del popolo cattolico in guerra con le ideologie straniere e i ceti coloniali, cioè la borghesia. L’ordine politico, a suo avviso, è l’espressione di un’unità culturale –Dio, patria e popolo- fondata sulla fede. E da Papa continua a predicare questa visione tipica della Controriforma. Non a caso la storia argentina è caratterizzata da violenza e autoritarismo, derivanti da una concezione della politica come scontro tra il bene e il male, il popolo e l’antipopolo.
Come influisce invece il retroterra gesuitico di Bergoglio?
ZANATTA. Nella Compagnia di Gesù convivono scuole diverse. Quella a cui appartiene Francesco non rinuncia all’idea della conquista di tutte le genti alla fede. Ci si può adattare alle più diverse situazioni, ma il fine resta una società armonica allergica al pluralismo. Bergoglio sta al liberalismo come Wojtyla stava al comunismo: lo considera un eterno nemico, il frutto avvelenato della secolarizzazione che corrompe il popolo di Dio. La rivoluzione di Francesco è un salto indietro generato dalla nostalgia per una purezza primigenia oggi rintracciabile nelle periferie del mondo.
Quindi è ostile alla modernità?
ZANATTA. Senza dubbio, anche se, come nota Diotallevi, vuole combatterla con le sue stesse armi. Ma dubito che questo indirizzo abbia favorito una modernizzazione peculiare. Il trionfo del peronismo in Argentina ha al contrario generato insuperabili difficoltà a fare i conti con la modernità.
E il Vaticano II?
ZANATTA. Ho l’impressione che in America latina il Concilio sia stato interpretato soprattutto in chiave di riscatto del sogno di realizzare il regno di Dio. Una visione sacralizzata della storia, di cui Bergoglio è partecipe.
Eppure è considerato di sinistra.
DIOTALLEVI. A questo ha contribuito lo sdoganamento del Papa operato da figure come Scalfari e Fazio. Nel peronismo non è decisivo il discrimine tra destra e sinistra, poiché al suo interno entrambe le tendenze sono presenti e si sono anche combattute. Quello che conta è invece l’opposizione tra il basso e l’alto, tra il popolo e l’élite. La sinistra italiana, moralista e populista, può quindi essere portata a percepire come vicino a sé un Papa portatore di questa concezione come Francesco. Bisogna inoltre considerare che nel peronismo alcuni tratti della modernità francese, come la sovranità del popolo, vengono recuperati, mentre lo scontro radicale è con la modernità anglosassone e le società aperte.
Che rilievo ha tale distinzione?
DIOTALLEVI. Nel Vaticano II esercita una forte influenza il cattolicesimo di lingua inglese: nella dichiarazione “Dignitatis humanae” sulla libertà religiosa c’è l’impronta del gesuita nordamericano John Courtney Murray. E il dialogo con la modernità anglosassone viene ripreso dai due papi successivi. Bergoglio si muove in una direzione diversa: il suo mito del popolo non ha spazio in una visione per cui la coscienza può volgersi al bene soltanto nella libertà e conserva i suoi diritti anche nel caso di una coscienza erronea (come insegna il Concilio). Non stupisce che la sinistra italiana, per la maggior parte assai poco liberale, trovi forti elementi di affinità con la cultura di Bergoglio, per molti versi più vicina all’eredità di Pio XII (e Leone XIII) che a quella del Concilio.
MENOZZI. Secondo me non si può prescindere dalla rappresentazione che Francesco dà di sé. E il discorso pubblico di Bergoglio nega che la Chiesa oggi possa impegnarsi nella ricostruzione di una cristianità. Chi lo pensa, aggiunge il Papa, svolge un’azione pastorale inefficace. Inoltre Francesco rifiuta l’idea che nella Chiesa possa esserci una contrapposizione tra conservatori e progressisti. La categoria a cui si richiama è piuttosto quella di riforma.
Con quali contenuti?
MENOZZI. La riforma si esplica sia sul piano interno sia nel rapporto tra Chiesa e società. Bergoglio ha compiuto atti che hanno cambiato il volto delle istituzioni ecclesiastiche. Ha riformato la Curia, ponendo al vertice della sua struttura il dicastero per l’evangelizzazione dei popoli al posto della segreteria di Stato, quindi con una prevalenza della pastorale sulla diplomazia. Ha impresso un nuovo indirizzo al dicastero per la dottrina della fede, assegnandogli il compito non di emettere condanne, come in passato, ma di promuovere gli studi e il dialogo tra le correnti teologiche: l’armonia di cui parla non è precostituita, nasce dal confronto. Inoltre ha avviato un cammino sinodale basato sulla tesi che ogni battezzato è corresponsabile nella soluzione dei problemi della Chiesa. Ha liquidato poi la distinzione tra liturgia ordinaria in lingua volgare e straordinaria in latino, inventata da Ratzinger nel tentativo illusorio di ricondurre nella Chiesa lo scisma tradizionalista lefebvriano.
Tali iniziative hanno avuto successo?
Menozzi. Se ne può discutere, ma l’intenzione riformatrice è indubbia. Lo stesso vale per i rapporti con la società. Pensiamo alla questione dei valori non negoziabili. Francesco nega che la legge naturale, valida per chiunque in ogni tempo e luogo, sia il criterio supremo attraverso cui la Chiesa deve rapportarsi con il mondo. A suo avviso è centrale il messaggio del Vangelo: la Chiesa deve diffondere nella società i suoi valori, ma il controllo ecclesiastico sulla vita delle persone non è più proponibile. Si tratta invece di animare cristianamente la vita collettiva attraverso un’intelligenza aggiornata della Scrittura da cui discendono gli appelli alla pace, alla fratellanza universale, alla misericordia. Valori sulla base dei quali la Chiesa può incontrare gli uomini di oggi per cambiare una società nella quale la dignità della persone è assai poco rispettata.
Tra i valori cristiani c’è anche quello della vita?
MENOZZI. Per Wojtyla e Ratzinger era un principio supremo, da cui derivava la ferma denuncia delle leggi che consentono l’aborto. In Francesco la condanna dell’aborto rimane, ma non ha la priorità assoluta, semmai si accompagna al rigetto della pena di morte e della guerra, anch’esse negatrici della vita. Insomma, può darsi che il concetto di riforma non appartenesse al pensiero di Bergoglio prima che diventasse Papa, ma spesso la funzione cambia chi l’assume. Molti Papi nella storia hanno cambiato posizione dopo l’elezione.
ZANATTA. Tra gli scarsi successi ottenuti da Francesco c’è quello di aver ribaltato le accezioni consuete di progressismo e conservazione. Di certo è ostile non solo alla modernità anglosassone, ma anche a quella francese, la quale ha ispirato il liberalismo argentino. E’ vero che Bergoglio accetta il principio della sovranità popolare, ma in una chiave organicista illiberale, certo non contrattualista. E quando dico agli argentini che in Italia è considerato un progressista, i miei interlocutori trasecolano, perché ricordano le sue invettive contro il matrimonio omosessuale, il divorzio, l’arte blasfema.
Eppure diversi laici lo apprezzano.
ZANATTA. Bergoglio modula il suo discorso a seconda della platea. Quindi coltiva la sensibilità progressista se interviene nell’Occidente secolarizzato, mentre promuove la rigidità dottrinale quando parla nel Sud del mondo, dove l’ideale della cristianità gli sembra minacciato dalle sirene individualiste.
DIOTALLEVI. Con il Vaticano II e Paolo VI la Chiesa si è confrontata con le società aperte di matrice anglosassone, caratterizzate dal rule of law, dalla rappresentanza, dal mercato, dalla democrazia, dalle istituzioni della libertà responsabile. Molto importante a tal proposito è il discorso di Berlino in cui Benedetto XVI nel 2011 dichiara che la Chiesa non vuole imporre i suoi valori, ma partecipare a una comune ricerca per la definizione dei diritti. Ma questa apertura al liberalismo nella storia del cattolicesimo non è la norma, bensì l’eccezione. Con Francesco si torna alle posizioni consuete di stampo comunitari sta, più vicine alla Politica di Aristotele che alle due spade di Agostino. Mentre il Vaticano II vede il conflitto tra poteri come un fattore positivo, che limita l’arbitrio dei governanti, Bergoglio dice che lo Stato deve garantire a tutti terra, tetto e lavoro, esprimendo una visione alternativa a quella cattolico-liberale che era prevalsa nel magistero.
Quindi Francesco non è un riformatore?
DIOTALLEVI. Non ne metto in dubbio la volontà innovatrice né la fedeltà al Concilio. Tuttavia la sua idea di evangelizzazione ha accenti molto diversi rispetto a Paolo VI. Il punto è che Bergoglio capita in un momento nel quale è l’Occidente ad aver rotto con sé stesso, tant’è vero che produce un’avanzata delle destre sovraniste, a cominciare dagli Usa. Quindi la chiusura della parentesi di una Chiesa amica della libertà, che porta Bergoglio a dire che non se la sente di negare alla Cina la qualifica di democrazia, coincide con una crisi più generale della civiltà liberale. Nonostante le note ragioni di scontro, per esempio sul tema dell’immigrazione, alcuni elementi stilistici e di contenuto avvicinano il magistero del Papa persino alle posizioni di Trump (si pensi al caso dell’Ucraina), proprio perché la contrapposizione tra élite e popolo rompe lo schema fondato sulle categorie di destra e sinistra.
E la sua linea geopolitica?
Menozzi. Riafferma la tradizionale autonomia della Chiesa. Neppure Pio XII aveva mai accettato di farsi cappellano dell’Occidente. E oggi Bergoglio segue una politica imperniata sul dialogo, che sollecita processi di pacificazione secondo il Vangelo. Non propone un’idea di cristianità ormai tramontata, ma un percorso di convivenza tra i popoli alternativo alle tendenze oggi in voga, dall’imperialismo putiniano al bullismo trumpiano.
Zanatta. Il terzomondismo di Bergoglio sarà forse la sua eredità più solida, anche perché nella Chiesa gli equilibri stanno da tempo cambiando a favore dei Paesi poveri.
D’altronde la solidarietà atlantica è oggi in forte crisi.
Zanatta. Sì, ma con Bergoglio viene svalutata proprio l’idea di una civiltà nutrita sia dal cristianesimo sia dall’illuminismo, nella quale fede e ragione possono dialogare. La sua modernità cattolica, frutto della tradizione ispanica, è ostile all’illuminismo. Per lui la ragione occidentale minaccia la spontanea religiosità delle genti, mentre apprezza il populismo russo e la matrice confuciana del comunismo cinese. In fondo la sua è una proiezione globale della terza posizione peronista che, sulla scia del fascismo italiano, si opponeva alle plutocrazie liberali come al marxismo ateo.
Il Papa banditore di una terza via?
Zanatta. Il peronismo affermava di ispirarsi alle encicliche papali. E la geopolitica di Bergoglio ne è l’ideale prolungamento. Il Papa pensa che i Paesi religiosi del Sud del mondo possano unirsi in un vago sincretismo spirituale in nome della triade Dio, patria e popolo, minacciata di erosione dall’universalismo liberale cosmopolita e miscredente.
Eppure Bergoglio si richiama anche ai padri democristiani dell’Europa.
ZANATTA. E’ un’altra dissimulazione. Non li aveva mai nominati prima di essere eletto Papa. Anzi considerava la Democrazia cristiana un peccaminoso cedimento alla modernità liberale. E’ vero che Francesco reclama la libertà religiosa, anche se nei Paesi islamici lo fa con molta timidezza, ma la civiltà occidentale significa anche pluralismo e diritti individuali.
Che effetto ha avuto il pontificato di Bergoglio sulla diffusione della fede?
DIOTALLEVI. I suoi anni hanno coinciso con un’accelerazione della crisi del cattolicesimo, a cui corrisponde la forte diffusione delle nuove spiritualità, di una religione fai da te. Non siamo dunque in un’epoca di trionfo della laicità, ma le difficoltà della Chiesa proseguono sotto la pressione del boom di una religione a bassa intensità. Il papato di Francesco non ne è stato certo la causa, ma certamente non si è sinora dimostrato un buon antidoto.
Però il Papa ha un notevole successo mediatico.
DIOTALLEVI. Sì, lo abbiamo visto intervenire anche al festival di Sanremo. Oggi le autorità religiose si vanno trasformando in celebrità che attirano audience più che sfidare le coscienze. Questo non fa che incentivare la secolarizzazione.
E il distacco dall’Occidente?
MENOZZI. Il problema è come tradurre la rivelazione in culture diverse dalla nostra, nella nuova consapevolezza che il Vangelo cambia nel corso del tempo, un’acquisizione decisiva che cambia il rapporto della Chiesa con il mondo rispetto alla dottrina tradizionale. Anche i dati sociologici relativi alla pratica religiosa –la frequenza alla messa, la partecipazione ai sacramenti, l’andamento delle vocazioni- non sono indici della fede cristiana, che è un fatto interiore, non rilevabile con strumenti quantitativi. Francesco distingue tra il secolarismo, la tendenza a espungere la religiosità da ogni dimensione della vita, e la secolarizzazione, che può anche costituire una via per riappropriarsi, da parte dei fedeli, di aspetti della spiritualità che la Chiesa aveva sottovalutato. Di qui la spinta del Papa a intavolare un dialogo anche con i non cattolici per trovare un terreno d’intesa volto alla costruzione di un mondo migliore.
Zanatta. A me pare che la sua provenienza dal cattolicesimo argentino, trionfalista e in passato assai popolare, impedisca a Francesco di percepire i rischi che implica il ritorno delle religioni sulla scena pubblica, da lui auspicato. Nei suoi discorsi al Sud del mondo la giusta distinzione tra secolarismo e secolarizzazione tende a sfumarsi. E la politica religiosa da lui invocata rischia di tradursi in movimenti e regimi che, unendo fede e cultura, vogliono imporre un’identità nazionale forte a discapito delle libertà individuali. Sta già accadendo con il nazional-islamismo, il nazional-induismo, il nazional-buddhismo, la nazional-ortodossia russa. Fenomeni rispetto ai quali la laicità occidentale, che Bergoglio non apprezza, rimane un bastione irrinunciabile.
Loris Zanatta Luca Diotallevi Daniele Menozzi